Collezione digitale
Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Vedi Scheda

Marmo
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Gesso, h. 202 cm
Donata da Ferdinando I al Museo dell'Università nel 1820.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ernesto Basile (Aula Magna)
1820 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: Ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Palazzo San Cataldo, Bagheria
L'Antinoo Farnese è una scultura marmorea del II secolo d.C., proveniente dalla collezione Farnese di Roma, oggi conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Rinvenuta in occasione degli scavi romani voluti da papa Paolo III intorno alla seconda metà del XVI secolo, la scultura trovò ben presto spazio all'ingresso alla Galleria dei Carracci nel palazzo Farnese di Roma. Intorno al 1786, per volere del re Ferdinando IV di Borbone, l'opera fu trasferita a Napoli assieme al resto della collezione Farnese.
L'opera, che rappresenta un ragazzo dal fascino malinconico, con volto tondo, guance piene e prive di qualsiasi peluria, labbra sensuali e folta capigliatura a grosse ciocche mosse, risale all'epoca adrianea, quando al ragazzo Antinoo, amante di Adriano, furono dedicate, in seguito alla sua morte, numerose sculture da parte dell'imperatore romano.
Sempre allo stesso periodo e sempre dal palazzo Farnese, risale infatti un'altra statua dedicata ad Antinoo nella quale il giovane è ritratto nelle sembianze di Dionisio. Anche quest'ultima versione è oggi esposta all'archeologico di Napoli.
La statua raffigura Antinoo, idealizzato ed eroizzato dopo la sua morte. Il giovinetto è stante sulla gamba destra, la sinistra lievemente retroflessa; il braccio destro è in riposo, lungo il corpo, il sinistro piegato in avanti. Il tipo iconografico riprende modelli greci del tardo V sec. a.C., ma la trattazione del corpo nudo è, in questo caso, molto più morbida, con la muscolatura accennata con lievi passaggi e le proporzioni allungate delle membra.
Il volto ha tratti fortemente idealizzati e coerenti col gusto classicistico dell'opera; la capigliatura è invece caratterizzata da una trattazione fortemente chiaroscurale, con folte ciocche uncinate ricadenti sulla fronte e sul collo.
Antinoo era il favorito dell'imperatore Adriano, il quale in seguito alla sua morte, avvenuta nel 130 d.C. in Egitto, diede inizio al suo culto e commissionò numerose statue, nelle quali il giovinetto è raffigurato nelle sembianze di Apollo, Dioniso, o riproducendo moltemplici noti tipi iconografici ed apponendovi il suo volto. Il culto di Antinoo non sopravvisse al regno di Adriano, ed a questo periodo va datato l'esemplare in esame. La statua proviene dalla collezione Chigi, acquistata da Pietro Bembo.
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo è stato realizzato, anch'esso come la scultura originale, con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, presenti in varie zone della superficie.
Il calco in gesso è cavo, probabilmente soggetto a patinatura, è scalfito in vari punti. In alcuni punti presenta una decoesione della patina originale. Presenta alcune parti mancanti: le braccia. Sull’addome è visibile un intervento di restauro non documentato.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero. Questo particolare gesso può essere preso a confronto per lo studio dei soggetti sacri della storia dell'arte e dei loro tratti iconografici distintivi.
Guida Ruesch 1908, n. 983; Marconi 1923; Maiuri 1957, pp. 52-53; Clairmont 1966, p. 50, n. 33; Zanker 1974, pp. 10-11, n. 9, tav. 5.4; Bianchi Bandinelli - Torelli 1976, n. 133; Collezioni Museo 1989, I.2, pp. 156-157, n. 24; Museo archeologico 1994, p. 331; Sculture Farnese 2003, pp. 18-19.
Marmo
Galleria degli Uffizi, Firenze
Gesso, h. 148
Donato da Ferdinando I al Museo dell’Università (cfr. n. 21, Inventario della Regia Università del 1857).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti.
1820 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo)
1867 - 1886: Ex Monastero della Martorana, Palermo)
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo)
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo)
L'Apollino o Apollo Medici è una copia romana di una scultura ellenistica dell'adolescente dio Apollo Lykeios di Prassitele, conservata oggi alla Galleria degli Uffizi a Firenze.
La sua testa ha proporzioni simili a quelle dell'Afrodite di Cnido di Prassitele e, quindi, si è sostenuto che fosse una copia di un originale di Prassitele, o almeno del suo ambito. Altri sostengono che è una creazione eclettica di epoca romana, mescolando diversi stili. Il suo braccio sinistro può aver tenuto un arco.
Fu rinvenuta a Roma nel XVII secolo, anche se la sua esatta provenienza non è nota. Collocata in origine nella collezione Borghese, fino a quando passò alla collezione Medici a Villa Medici, dove venne registrata nel 1704. A differenza di molte sculture antiche della collezione medicea, non fu portata a Firenze da Cosimo III de' Medici, rimanendo a Roma fino a quando non venne spostata per accompagnare la Niobe Medici nel 1769-1770. La fortuna critica della statua avrà il suo apice lungo tutto il XVIII° secolo, considerata come una delle sculture romane più copiate.
Fu vista nella Tribuna degli Uffizi dal poeta inglese Percy Bysshe Shelley, che la descrisse così: "È difficile immaginare qualcosa di più delicato bello che il Ganimede; ma la leggerezza dello spirito simile, la morbidezza, la perfezione fluente di forme dell’Apollino, lo superarano. Il volto, anche se squisitamente bello e gentile, non è divino. Attraverso le arti ci sembra scorrere uno spirito di vita che dà loro leggerezza. Nulla può essere più perfettamente bello delle gambe, e l'unione dei piedi con le caviglie, e il venir meno delle linee dei piedi alle estremità delicate. E 'come uno spirito anche nei sogni. Il collo è lungo ma pieno, e sostiene la testa con la sua profusione dove si annodato i capelli, come se non avesse bisogno di alcun sostegno".
Nel 1840, nella sua collocazione agli Uffizi, l'opera fu danneggiata perché vi cadde sopra un dipinto; in quell'occasione fu restaurata da Lorenzo Bartolini , che ricoprì l'intera statua con uno strato di vernice per mascherare le riparazioni. Oltre a molte copie XVII° e XVIII ° secolo, nota è quella realizzata in marmo dallo scultore francese Jean-Baptiste Vietty negli anni venti dell'Ottocento, conservato nel giardino del Musée des Beaux-Arts di Lione. C'è anche un "Apollino Milani" a Firenze, conservata presso il Museo Archeologico Nazionale.
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo, da un'indagine documentaria, risulterebbe essere tratta dalla copia in marmo dello scultore francese Jean-Baptiste Vietty, oggi conservata al Musée des Beaux-Arts di Lione. La notizia è suffragata da un inventario del Museo di Antichità e Belle Arti risalente al 1822, nel quale vengono citatati quattro gessi, originariamente collocati nell'ex Casa dei Padri Teatini di Palermo. L'indicazione invetariale recita: “Ricevo del custode sig. D. Camillo Paderni delli quattro gessi attribuiti a Vietty, e ricuperati da’ P.P. Gesuiti, alligato ad oggi (?) del 15 giugno 1823”. Non si hanno notizie sugli altri tre gessi.
Il calco in gesso è cavo, probabilmente soggetto a patinatura, è scalfito in vari punti. In alcuni punti presenta una decoesione della patina originale. Il braccio destro risulta mancante a causa del trasporto da Palazzo Fernandez ai Mulini Virga, rottura più antiche sono quelle delle due dita della mano sinistra e ad un dito del piede destro. Tra gli interventi storici si segnala quello di Carmelo, che interviene nel 1854 riattaccando il collo e il braccio destro, rotture provocate in seguito alla bomba caduta sulla Galleria dell’Università nel 1848. Tra il 2001 e il 2002, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti la restaura nel braccio, nell’avambraccio e mano destra, e in piccoli particolari del corpo.Nel tempo sono stati effettuati altri restauri non documentati, come il ricollocamento dell’avambraccio sinistro. Tra il 2009 e il 2011 Sophie Bonetti, in collaborazione con gli alunni del Corso di Restauro, ne effettuano la pulitura.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero.
Inventari oggetti di antichità della Regia Università, faldone 1362, Fondo Archivio Storico dell’Università degli Studi di Palermo, Archivio Storico dell’Università di Palermo, Palazzo Steri, Carpetta n. 13, Museo di Antichità e Belle Arti ossia Quadreria, Sala de’gessi, punto 4.
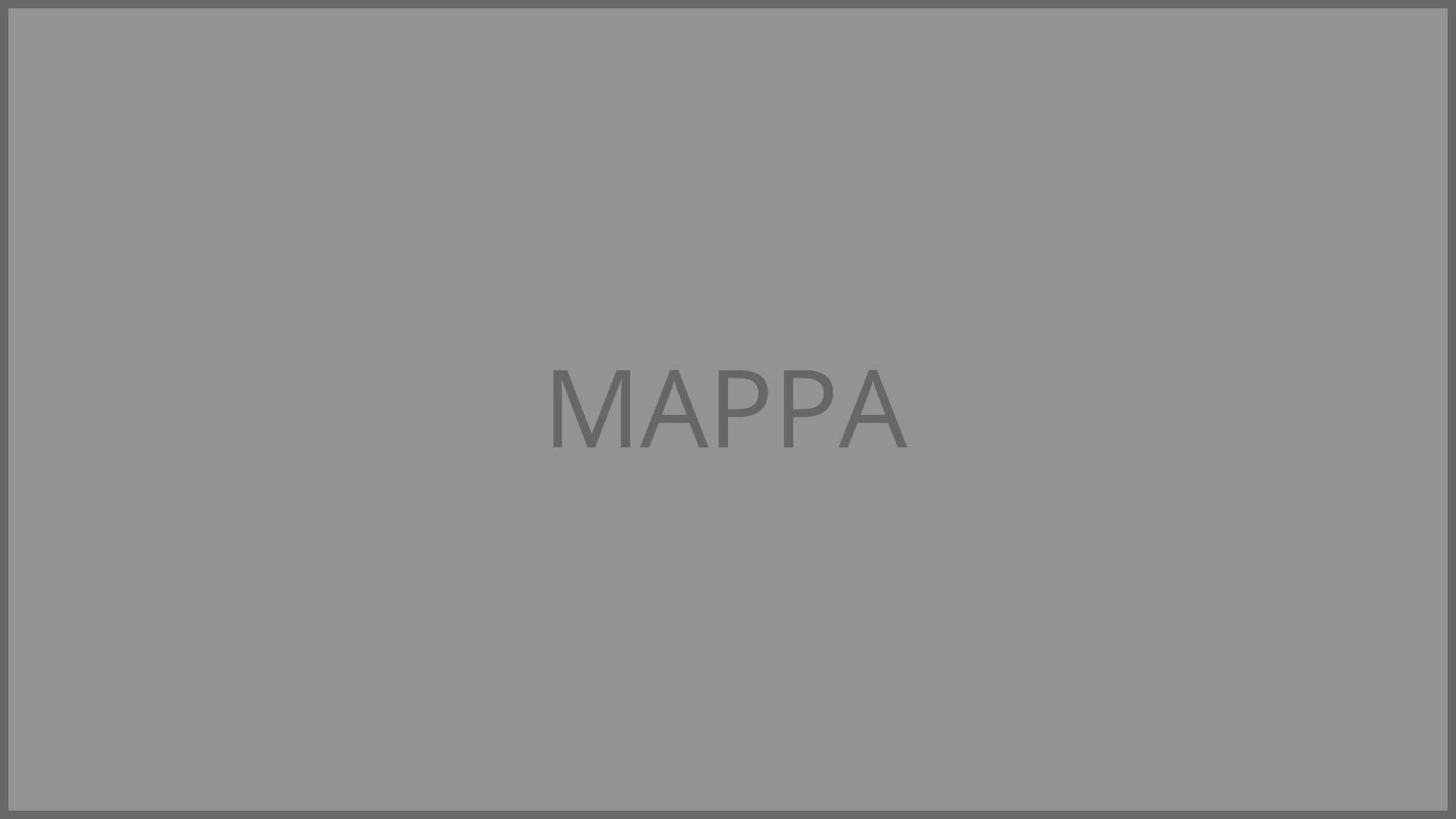
Marmo pentelico, h. 155 cm
Museo del Louvre, Parigi
Gesso, h. 162 cm
L’opera fu acquistata dalla Reale Università di Palermo nel 1825(?).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Palermo, Sala Salvatore Valenti
1825(?) - 1867: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: ex monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo, Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Il Gladiatore Borghese è una scultura greca databile al I secolo a.C. circa, che, secondo quanto indicato sul piedestallo, sarebbe opera di Agasias, figlio di Dositeo; oggi è conservata nel Museo del Louvre di Parigi. La statua fu portata alla luce da scavi casuali effettuati nel 1609 nel territorio dell'odierna Anzio, vicino Roma. Il capolavoro della scultura greca, al momento del ritrovamento, era ridotto in 17 frammenti, poi ricomposti nel 1611 dal primo restauro effettuato ad opera dello scultore Nicolas Cordier. La statua è chiamata così perché appartenente alla Collezione Borghese, fino al 1808, quando fu legalmente venduta dal proprietario a suo cognato, Napoleone Bonaparte, per essere poi acquisita alle collezioni del Museo del Louvre di Parigi, dove attualmente è conservata ed esposta nella Galleria Daru, dopo l'ultimo restauro effettuato dal Dipartimento delle Antichità Greche, Etrusche e Romane del Museo del Louvre, nel periodo compreso tra aprile 1996 e giugno 1997.
Il Gladiatore, in equilibrio nello spazio, è ritratto nel gesto di proteggere sé stesso, dall'attacco dell'avversario, con il proprio scudo, probabilmente di bronzo ed un tempo attaccato al braccio sinistro in guardia. La scultura di Agasias, porta i segni inconfondibili dell'influenza di un altro grande scultore greco del periodo ellenistico, Lisippo, vissuto nel IV secolo a.C., e riprende proprio da lui, lo stile dell'eroismo atletico, però con il pathos (sentimento) del periodo ellenistico. La qualità lineare dei lavori di Lisippo, tuttavia, viene da Agasias trasformata nella drammaticità dell'azione. In questa opera meravigliosa, l'artista dimostra inoltre di aver una sorprendente conoscenza dell'anatomia del corpo umano, cosa alquanto rara per il tempo in cui egli visse. La muscolatura guizzante del Gladiatore, la sua linea, il gesto atletico e l'armonia della figura, fu oggetto di studio e di ammirazione di un altro grande scultore italiano del neoclassicismo: Antonio Canova. È plausibile che tale statua fu presa a modello dal Bernini per il suo David.
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo è stato realizzato, anch'esso come la scultura originale, con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, presenti in varie zone della superficie.
Mancano le braccia, il tronco è stato completamente ricostruito; sulla superficie sono ancora gli interventi di restauro nella coscia, nella gamba e nel piede destro. Interventi precedenti: rinforzato con ferro in diversi punti da Carmelo Vanni nel 1854, a seguito della bomba caduta sulla galleria dell’Università nel 1848; per i danni provocati dal trasporto dalla Ex casa dei Padri Teatini alla Martorana, lo restaura Vincenzo Ragusa nel 1867. Fra il 2003 e il 2004, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti la restaura alla base e all’anca destra. Tra il 2009 e il 2011 Sophie Bonetti, in collaborazione con gli alunni del Corso di Restauro, ne effettuano la pulitura.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero.
Inventari oggetti di antichità della Regia Università, 1857, p. 66, n. 25, Fondo Archivio Storico dell’Università degli Studi di Palermo, Archivio Storico dell’Università di Palermo, Palazzo Steri.
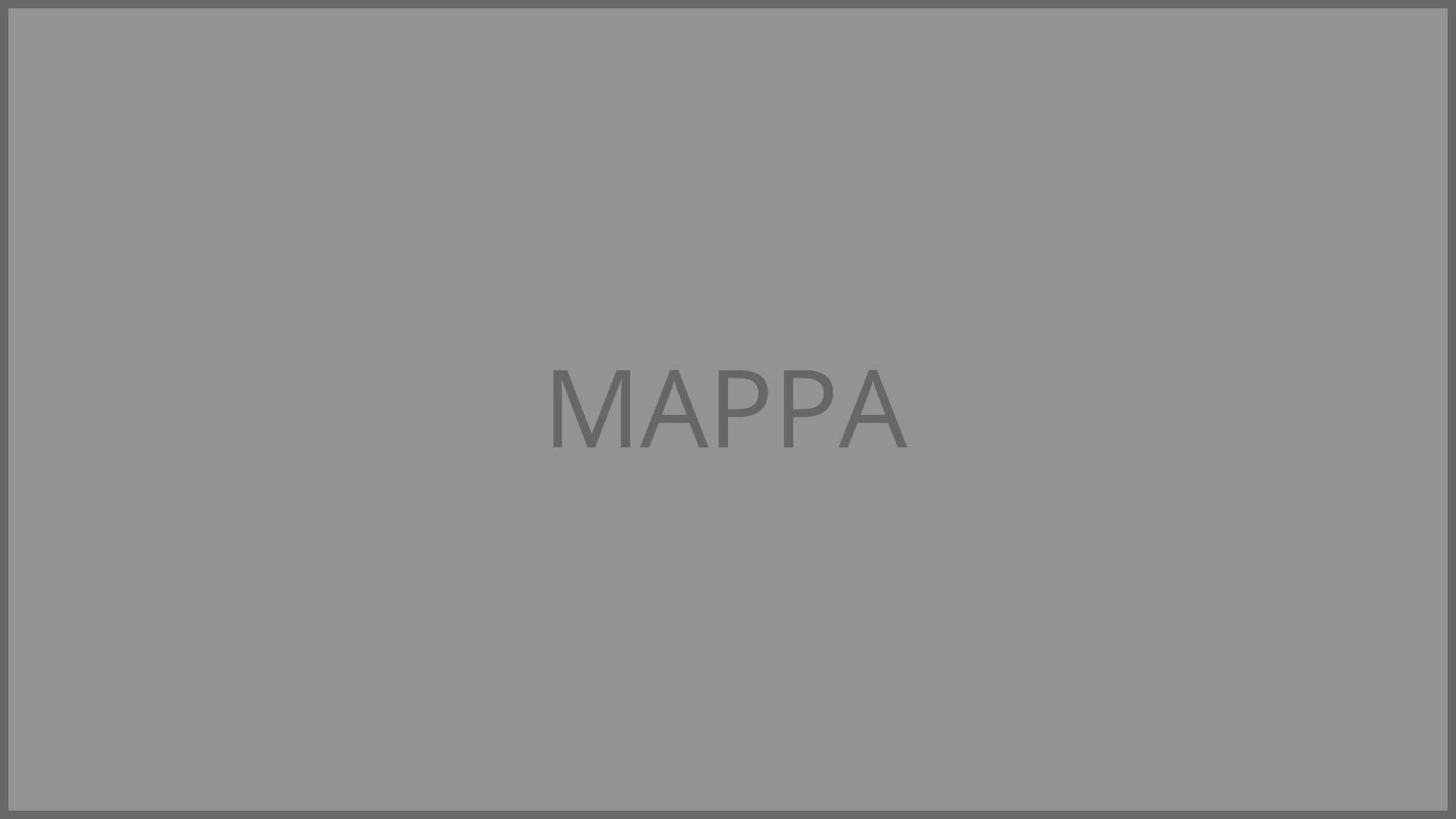
Marmo, h. 224 cm
Musei Vaticani, Città del Vaticano
Gesso, h 240 cm
Copia romana da originale in bronzo di Leocares (IV sec. a.C.)
La copia fu donata dal Finocchiaro al Museo della Reale Università di Palermo nel 1826.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Palermo, Sala Mario Rutelli.
1822 - 1867: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: ex monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Villa San Cataldo, Bagheria, Palermo
La scultura è una copia in marmo della seconda metà del II secolo a.C. di un’opera in bronzo attribuibile a Leocares del IV secolo a.C. Fu trovata nel 1489 nei giardini di Nerone ad Anzio, quindi non era una statua venerata in un tempio ma solo ornamento per i giardini, e appartenne al cardinale Giuliano della Rovere, futuro papa Giulio II (1503-1513). Nel 1506 si trovava ancora nel giardino del palazzo del cardinale presso SS. Apostoli, finché non fu trasportata nel 1508 in Vaticano, menzionata nel 1509 nel Cortile delle Statue e solo nel 1511 definitivamente collocata insieme alla statua del Laocoonte e alla Venus Felix in una delle tre nicchie nella parete principale del cortile del Belvedere, da cui la statua trae l’appellativo. Da questo podio la statua cominciò ad attirare su di sé l’attenzione ammirata del gran pubblico. L’importanza di questa statua nella storia dell’arte sta nel fascino e nell’influsso che ha esercitato nel corso dei secoli, spesso replicata e adattata per altre figure. A pochi anni dalla sua scoperta Albrecht Dürer (1471-1528) vi si ispirò per l’incisione di Adamo e Eva, tre secoli dopo Antonio Canova (1757-1822) per Perseo trionfatore, o Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), considerato il teorico del neoclassicismo.
La statua dell’Apollo Pitio, detto del Belvedere, in marmo bianco, alta 224 centimetri, rappresenta il dio, che avanza dopo aver ucciso Pitone, un drago-serpente di grandi dimensioni proveniente da Delfi. Tra gli dei pagani Apollo era, per vari motivi, il più raffigurato, tra le molte statue veniva rappresentato dinamico e sorridente, efebico e sensuale, ma è proprio in riferimento all’Apollo del Belvedere, che si è costituita la qualifica di “bellezza apollinea”, a significare un volto perfetto o un corpo di mirabili proporzioni. È completamente nudo ma porta un mantello che ricade sul braccio sinistro; l’impostazione è un’evoluzione di quella policletea, con un corpo sottile e dai tratti piuttosto femminili. Il volto ornato da fluidi boccoli cinti da una fascia ornamentale e che ricadono sul collo, presenta un’elaborata acconciatura per Apollo, che tradizionalmente aveva i capelli lunghi, introducendo una nuova concezione del dio olimpico. Nel 1532/33 fu restaurata da Giovanni Angelo Montorsoli (1507 ca – 1563) che rimosse alcune parti e aggiunse la parte inferiore del braccio sinistro quello con la clamide e la mano destra, mancanti al momento del ritrovamento, come si può vedere nel disegno del Codice Escurialense.
Il calco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo, di cui non è stato possibile rintracciare il formatore e la data, è stato realizzato con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, presenti in varie zone della superficie.
L’opera si trova in un pessimo stato di conservazione, dovuta ai vari spostamenti e avvenimenti della sua storia. La superficie si presenta scura e graffiata in diversi punti. Manca l’avambraccio sinistro e presenta diverse lacune. Nel 1848, in seguito ai danni provocati dalla bomba caduta sulla Galleria dell’Università, viene riattaccata nel dorso, nel drappo e nelle braccia. Nel 1854 viene rinforzata con supporto in ferro nella schiena da Carmelo Vanni. Nel 1876, per i danni provocati nel trasporto dall’ex Casa dei Padri Teatini, viene restaurata da Vincenzo Ragusa. Tra il 1995 e il 1996, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore. Rizzuti la restaura al braccio sinistro, al drappeggio, al braccio, al ginocchio e alla coscia destra. Tra il 2006 e il 2007 ancora un intervento di Rizzuti vedrà il recupero di parte del panneggio, del braccio sinistro e della testa. Negli anni ha subìto numerosi altri interventi di restauro, non tutti documentati.
La conservazione dei calchi in gesso della Gipsoteca dell’Accademia di Palermo mira a far a conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Attraverso le copie gli studenti provenienti da diversi corsi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa, il disegno dal vero, la riproducibilità, la resa fotografica e il loro allestimento.
R. Bianchi Bandinelli, Apollo di Belvedere, in « La critica d'arte: rivista bimestrale di arti figurative», A. 1, n. 1 (ott. 1935/36), p. 3-9; D. M. Child, The Apollo Belvedere and the Garden of Giuliano della Rovere at SS. Apostoli, London 1986; G. Lajolo, Discorso nella ricorrenza del 500 anniversario dell’acquisizione dell’Apollo del Belvedere alle collezioni vaticane: 9 ottobre 1508 – 2008, in «Bollettino / Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie», n. 26, 2007/08(2009), pp. 15-20.
Marmo, h. 183 cm
Musei Capitolini, Palazzo Nuovo, Sala del Galata, Roma
Gesso, h. 183 cm
Donato dal Finocchiaro al Museo della Real Università di Palermo nel 1826.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Sala Ernesto Basile, Aula Magna
1826 - 1867: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: ex monastero della Martorana, Palermo
1886 - 1933: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
La statua è una copia romana della prima età antoniniana , da originale probabilmente della seconda metà del III sec. a.C.. È conservata a Roma, Musei Capitolini, Palazzo Nuovo, Sala del Galata. Proviene dagli scavi del 1701 nella “Villa degli Antonini”, situata tra il XVIII e XIX miglio della Via Appia antica nel territorio dell’antica Lanuvium , tra Genzano e Lanuvio, e poi passò nella collezione Albani.
Si tratta di una statua in marmo bianco a grana fine con venature grigie, alta 185 cm. La scultura fu restaurata poco dopo il rinvenimento, infatti appare già integrata nei disegni fatti eseguire da R. Topham, 1720-1730 circa. La figura, gravitante sulla gamba sinistra, con la destra lievemente flessa e scartata di lato, rappresenta un uomo anziano, vestito con un pesante mantello dalle ampie pieghe che lascia scoperto il torace, si ripiega intorno all’addome e giunge al di sotto delle ginocchia. Le parti nude mostrano i segni dell’età avanzata con fronte rugosa e occhi piccoli. La testa, inclinata verso il basso e lievemente rivolta alla sua destra, ha una capigliatura corta, con ciocche sottili le cui punte coprono parte della fronte, la barba e baffi folti. La statua dopo il ritrovamento divenne presto famosa e fu spesso disegnata e riprodotta, interpretata dapprima come il cinico Diogene, poi come il filosofo Zenone di Cizico, in seguito è prevalsa l’ipotesi che raffiguri un cinico, sulla base di caratteristiche iconografiche riferite agli appartenenti a questa scuola, i quali vestivano un pesante mantello, camminavano scalzi e non curavano la persona. Nel contesto della “Villa degli Antonini”, una statua di filosofo aveva sicuramente un suo ruolo, indicativo degli interessi culturali dei proprietari.
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo è stato realizzato, anch'esso come la scultura originale, con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, presenti in varie zone della superficie.
Il calco in gesso, è scalfito in vari punti. Presenta alcune parti mancanti: la maggior parte del braccio destro. Mancano piccole parti nei piedi e nella base d’appoggio. Tra il 2001 e il 2002, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti la restaura nel piede destro, nella parte posteriore inferiore della tunica e in diversi particolari del corpo.
La conservazione dei calchi in gesso della Gipsoteca dell’Accademia di Palermo mira a far a conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Attraverso le copie gli studenti provenienti da diversi corsi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa, il disegno dal vero, la riproducibilità, la resa fotografica, il loro allestimento.
M. G. Picozzi in L’età dell’equilibrio Roma Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio 98-180 d.C., catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini 2012-2013) a cura di E. La Rocca, C. Parisi Presicc e con A. Lo Monaco, Roma 2012, cat. I.34.10, p. 285.
Marmo, h. 192 cm
Arte Romana Antica dalla Villa dei Papiri (Ercolano), Museo Archeologico Nazionale, Napoli
Gesso, h. 192 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 65 Inventario 1857, n. 5).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ernesto Basile
1826 - 1867: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
La struttura risulta buona, presenta sporco e depositi superficiali. Mancano piccole parti negli alluci. Sono visibili sulla superficie scultoria graffi in molti punti e una piccola rottura nel mignolo della mano destra, anulari di entrambi i piedi.
Nessun intervento documentato.
Marmo, h. 194 cm
Museo Archeologico Nazionale, Napoli (inv. 6232)
Gesso, h. 194 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 65 Inventario 1857, n. 5).
Accademia di Belle Arti di Palermo, Palazzo Fernandez, Sala Ernesto Basile.
1826 - 1867: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
La struttura risulta buona, presenta sporco e depositi superficiali. Mancano piccole parti negli alluci. Sono visibili sulla superficie scultoria graffi in molti punti e una piccola rottura nel mignolo della mano destra, anulari di entrambi i piedi.
Nessun intervento documentato.
Marmo, h. 173 cm
Dalla statua in precedenza a Pompei, Museo Nazionale di Napoli. Druso, il fratello minore di Tiberio, o Marcello, nipote di Augusto.
Gesso, h. 173 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 65 Inventario 1857, n. 5).
Accademia di Belle Arti di Palermo, Palazzo Fernandez, Sala Ernesto Basile.
1827 - 1867: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 1993: Palazzo Fernandez, Palermo
1993 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme La struttura risulta buona. La superficie risulta graffiata in diversi punti, presenta sporco superficiale, in maggiore concentrazione nella parte superiore del busto e in quella inferiore del drappo. Manca la testa, il braccio destro, la mano sinistra e parti delle dita dei piedi. La caviglia sinistra risulta rotta. Anche la base mostra delle fratture.
Tra il 2001 e il 2002, n seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore. Rizzuti la restaura al piede sinistro, nella parte posteriore e in varie parti per il corpo. Inoltre crea un ancoraggio metallico per tenere assieme la figura e la base.
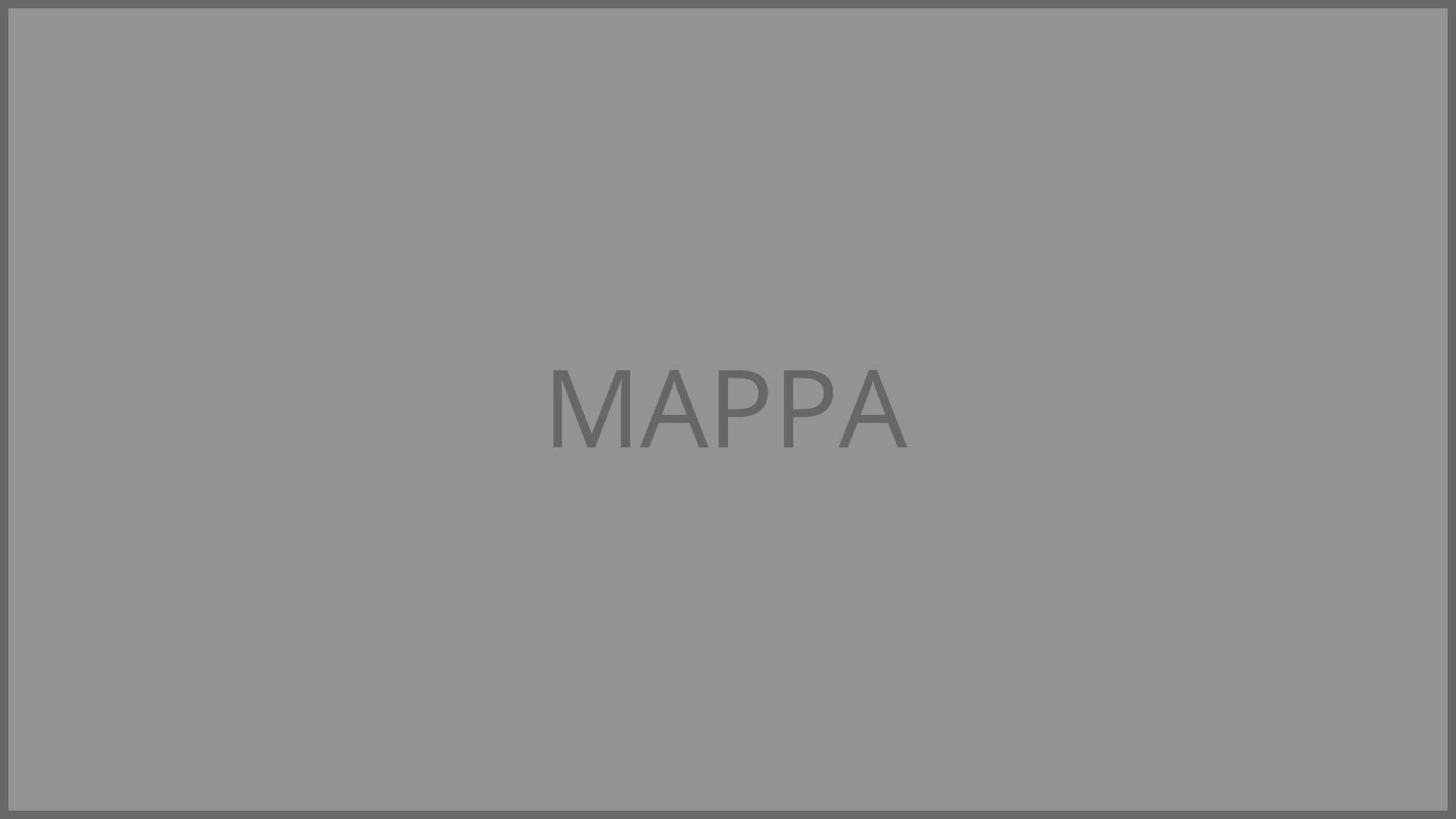
Bronzo, h. 200 cm
Rinvenuta nel XVIII sec. nel Teatro d'Ercolano, Museo Archeologico Nazionale, Napoli (inv. 5589).
Gesso; h. 192 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 65 Inventario 1857, n. 10).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ernesto Basile.
1827 - 1867: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 1993: Palazzo Fernandez, Palermo
1993 – 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2004: Villa San Cataldo, Bagheria
La superficie si presenta sporca e graffiata in diversi punti. Mancano il naso, parti del braccio destro e della mano sinistra.
Tra il 2003 e il 2004, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti la restaura alla base.Nel corso del tempo ha subito altre rotture e traumi ma non sono stati effettuati ulteriori interventi.
Marmo, h. 85 cm
Musei Capitolini, Roma (?)
Gesso, h. 85 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 65 Inventario 1857, n. 23).
Aaccademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti.
1827 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: Ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
La struttura risulta buona, presenta sporco e depositi superficiali.
Nessun intervento documentato.
Marmo rosso antico, h. 167,5 cm
Musei Capitolini, Roma
Gesso, h. 170 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 66Inventario 1857, n. 24).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti
1826 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: Ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
La struttura risulta buona, presenta sporco e depositi superficiali. Sono visibili sulla superficie graffi in molti punti. Il piede destro, parte del piede sinistro, e il braccio destro ad altezza gomito risultano ricostruiti.
Tra il 1995 e il 1996, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti la restaura ricostruendo il dito mignolo della mano sinistra, le prime quattro dita del piede destro, l’alluce del piede sinistro e parte della base. Interviene sulla “lira”, sulla base e sul braccio destro. Ulteriori interventi di ripristino vengono effettuati da Rizzuti tra il 2003 e il 2004.
Marmo, h. 149 cm
Museo del Louvre, Parigi
Gesso, h. 162 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 65 Inventario 1857, n. 5).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti.
1827 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: Ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme l’opera presenta numerose scalfiture, depositi superficiali di sporco e incrostazioni. Mancano il braccio destro e la mano sinistra.
Nel 1854, a seguito dei danni provocati dalla bomba caduta sulla Galleria dell’Università nel 1848, Carmelo Vanni interviene riattaccando collo, braccio, cosce e tronco alla scultura. Altri restauri, non documentati, sono visibili sulla spalla destra.
Marmo, h. 182 cm
Rinvenuta durante gli scavi Chigi (1779-1780) a Castelporziano, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, Roma.
Gesso, h. 182 cm
Donato nel 1827 al Museo dell’Università di Palermo da Francesco I (v. p. 65 Inventario 1857, n. 5).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler.
1827 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: Ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Villa San Cataldo, Palermo
Mancano le braccia. La superficie si presenta scalfita in diversi punti. La base è spezzata in due parti. Sono presenti anche macchie di ruggine. La gamba destra risulta frammentaria.
Nessun intervento documentato.
Marmo, h. 216 cm
Sala del Sileno, Galleria Borghese, Roma
Gesso, h. 214 cm
Da prototipo attribuito a Lisippo (IV secolo a.C.), con braccia con cembali aggiunte da Berthel Thorvaldsen.
Formato dai fratelli Gheraldi di Roma e spedito dal direttore dell’Istituto di Belle arti di Roma in occasione dell’apertura dell’Istituto di Belle Arti di Palermo nel 1886 per incarico del Ministero della Pubblica Istruzione. Arriva a Palazzo Fernandez il 31 gennaio del 1887 (v. Giornale delle entrate e delle uscite degli oggetti mobili dell’inventario dell’Istituto delle Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 193, p. 74).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ernesto Basile.
1887 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme la struttura risulta buona e la superficie ha ricevuto una probabile pulitura. Presenta leggere lesioni lungo le gambe. Mancano le braccia e la superficie si presenta graffiata in diversi punti. Alla base sono presenti delle lacune.
Nessun intervento documentato.
Marmo pario, h. 202 cm
Museo del Louvre, Parigi (n. 339)
Gesso h. 205 cm
Formato dai fratelli Gheraldi di Roma e spedito dal direttore dell’Istituto di Belle arti di Roma in occasione dell’apertura dell’Istituto di Belle Arti di Palermo nel 1886 per incarico del Ministero della Pubblica Istruzione. Arriva a Palazzo Fernandez il 31 gennaio del 1887 (v. Giornale delle entrate e delle uscite degli oggetti mobili dell’inventario dell’Istituto delle Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 195, p. 74).
Fratelli Gheraldi, Roma
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala delle Veneri
1887 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme presenta la superficie scalfita in diversi punti, accumuli e depositi di polvere e sporco.
Nessun intervento documentato.
Marmo, 92x 170 cm
Particolare degli Elgin Marbles (fregio ovest del Partenone), British Museum, Londra
Gesso, 92x170 cm
Formato dai fratelli Gheraldi di Roma e spedito dal direttore dell’Istituto di Belle arti di Roma in occasione dell’apertura dell’Istituto di Belle Arti di Palermo nel 1886 per incarico del Ministero della Pubblica Istruzione. Arriva a Palazzo Fernandez il 31 gennaio del 1887 (v. Giornale delle entrate e delle uscite degli oggetti mobili dell’inventario dell’Istituto delle Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 196, p. 74).
Fratelli Gheraldi, Roma
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti
1887 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Villa San Cataldo, Palermo
Nell’insieme l’opera verte in buone condizioni strutturali. Risulta leggermente graffiata in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
M. Beard, Il Partenone (Profile, 2002); B. Cook, Elgin’s Marbles (British Museum Press, 1984); I. Jenkins, Il Fregio del Partenone (British Museum Press, 1994); I. Jenkins, Il Partenone. Sculture nel British Museum (British Museum Press, 2007); I. Jenkins, Sull’architettura greca e la sua scultura nel British Museum (British Museum Press, 2006); I. Jenkins, K. Morton, Esplora il Partenone - un antico tempio greco e le sue sculture (British Museum Press, 2009); W.St Clair, Lord Elgin’s marble (3a edizione Oxford University Press, 1998).
Marmo, 125x148 cm
Particolare degli Elgin Marbles (fregio ovest del Partenone), British Museum, Londra
Gesso, 92x170 cm
Formato dai fratelli Gheraldi di Roma e spedito dal direttore dell’Istituto di Belle arti di Roma in occasione dell’apertura dell’Istituto di Belle Arti di Palermo nel 1886 per incarico del Ministero della Pubblica Istruzione. Arriva a Palazzo Fernandez il 31 gennaio del 1887 (v. Giornale delle entrate e delle uscite degli oggetti mobili dell’inventario dell’Istituto delle Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 197, p. 74).
Fratelli Gheraldi, Roma
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ernesto Basile
1887 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme, la superficie è graffiata in alcuni punti. Mancano le gambe, parti delle cosce ed entrambe le braccia.
Nessun intervento documentato.
M. Beard, Il Partenone (Profile, 2002); B. Cook, Elgin’s Marbles (British Museum Press, 1984); I. Jenkins, Il Fregio del Partenone (British Museum Press, 1994); I. Jenkins, Il Partenone. Sculture nel British Museum (British Museum Press, 2007); I. Jenkins, Sull’architettura greca e la sua scultura nel British Museum (British Museum Press, 2006); I. Jenkins, K. Morton, Esplora il Partenone - un antico tempio greco e le sue sculture (British Museum Press, 2009); W.St Clair, Lord Elgin’s marble (3a edizione Oxford University Press, 1998).
Marmo, 71x70,5 cm
National Gallery of Art, Washington (D.C.)
Gesso (frammentaria), 30x23 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel novembre 1827 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 658, p. 76) dal formatore Eduardo Pierotti di Milano.
Eduardo Pierotti, Milano
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1887 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Scalfito in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Marmo, 110x275 cm
Portico della Basilica di SS. Apostoli, Roma
Gesso, 110x275 cm
Acquistata dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel settembre 1891 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 842, p. 81) da Salvatore Valenti.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1891 - 2001: Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Palermo
La collocazione a muro ha permesso una buona conservazione.
Nessun intervento documentato.
Marmo, h. 153 cm
Galleria degli Uffizi, Firenze
Gesso, h. 138 cm
Fu acquistata dal Reale Istituto di Belle Arti nel 1896.
Orazio Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala delle Veneri (piano terra)
1896 - 1934(?): Palazzo Fernadez, Palermo
1934(?) - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Da gennaio 2005: Palazzo Fernandez, Palermo
Sull’intera superficie sono presenti depositi di polveri, sporco, graffi e scalfiture. L’opera è acefala e mancante delle braccia. Il tronco e la base mantengono la loro patina naturale date dal tempo. È presente del colore acrilico, probabilmente dovuto a un intervento di restauro da parte di studenti dell’Accademia.
2001-2002: in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti la restaura al piede destro, al ginocchio sinistro, alla spalla sinistra e interviene anche sul delfino. Nel corso degli anni sono stati effettuati altri piccoli interventi in varie parti:sottoginocchio e gamba destra, caviglia e piede sinistro, parte della base d’appogio e del tronco dietrostante.
Marmo, h. 170 cm
Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, Siracusa
Gesso, h. 170 cm
Una copia acquistata e un’altra regalata dal formatore Gioacchino Brocia all’Istituto di Belle Arti nel giugno del 1897.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala delle Veneri
1897 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000-2004: Mulini Virga, Palermo
da gennaio 2005: Palazzo Fernandez, Palermo
La Venere Landolina è una scultura marmorea, copia romana del II sec. d.C, da un originale di scuola rodio-asiatica della prima metà del II secolo a.C., conservata nel Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. Fu trovata nel 1804 da Francesco Saverio Landolina in un ninfeo negli Orti Bonavia, nell’ambito del “Giardino Spagna”, dal nome della famiglia proprietaria, e oggi sede dell’attuale Ospedale Civile. L’Opera, ispirata ad una creazione prassitelica, dalla sensualità del nudo prosperoso, è stata molto celebrata; nel 1885 Guy de Maupassant passando da Siracusa la descrisse in modo entusiasmante, ed è considerata una delle più importanti del Museo Archeologico di Siracusa. Nel 1896 la Direzione dell’Istituto di Belle Arti di Palermo prendeva accordi con il formatore Gioacchino Brocia per eseguire la forma tassellata sull’originale della Venere conservata a Siracusa. Delle sei riproduzioni della statua, al prezzo di £ 120 ciascuna, l’Accademia di Torino e l’Istituto di Belle Arti di Venezia acquistarono una copia ciascuno, due copie quello di Firenze.
La statua non ha la testa e il braccio destro. È quasi nuda, solo il bacino è coperto da un leggero tessuto a pieghe trattenuto dalla mano sinistra, che si allarga dietro come gonfiato dal vento a formare una specie di conchiglia, sulla quale si appoggia a sinistra un piccolo delfino, con la coda e la testa in basso verso la base della statua. Il braccio destro rotto doveva essere piegato al gomito e appoggiato sul petto per coprirlo, come suggeriscono gli appoggi rimasti sul torace, braccio sinistro e seno. Si conoscono varie copie della statua, tra cui una completa della testa, ma di fattura più tarda, conservata al Museo Archeologico Nazionale di Atene.
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo è stato realizzato, anch'esso come la scultura originale, con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, presenti in varie zone della superficie.
Nell’insieme presenta molteplici e sparse scalfitture in tutta la superficie, depositi di sporco e incrostazioni. Vi sono delle scritte dovute ad atti vandalici sul lato sinistro nella parte posteriore. Il braccio sinistro è spezzato nella parte superiore e all’altezza del polso. Risulta spezzata in due parti all’altezza delle gambe, sotto i glutei. Non si registrano interventi di restauro documentati.
La conservazione dei calchi in gesso della Gipsoteca dell’Accademia di Palermo mira a far a conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Attraverso le copie gli studenti provenienti da diversi corsi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa, il disegno dal vero, la riproducibilità, la resa fotografica, il loro allestimento.
C. Ciurcina, Siracusa in età ellenistica e romana, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” Siracusa, 2006 Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istituzione, Canicattini Bagni (SR), fig. 4, p.25.
Marmo, 123x94 cm
Museo dell’Ara Pacis, Roma
Gesso, 123x94 cm
Acquistato, assieme ad altri particolari decorativi, dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel giugno 1910 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 2218, p. 90).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Santa Rosalia, piano terra
1910 – 1933(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1933(?) - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Scalfito in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Marmo pario, h. 245 cm
Museo del Louvre, Parigi
Gesso, h. 243 cm
Donata al R. Istituto di Belle arti di Palermo nel settembre 1911 dal Ministero della Pubblica Istruzione (v. Giornale delle entrate e delle uscite degli oggetti mobili dell’inventario dell’Istituto delle Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 2377, p. 90).
Fratelli Gheraldi, Roma
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Benedetto Civiletti
1911 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
L’opera si presenta lacunosa nella base, si evidenziano scalfiture in alcuni punti della superficie.
Nessun intervento documentato.
Marmo, 104x144 cm
Collezione Boncompagni Ludovisi, Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps, Roma
Gesso,
bassorilievi del sarcofago:
a) Ierodula che suona il flauto, 84x72 cm
b) Nascita di Venere, 88x114 cm
c) Sacerdotessa che offre incenso, 84x70 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Scalone (secondo piano)
Fino al 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
L’opera si presenta in buono stato di conservazione, grazie alla collocazione stabile a parete.
Nessun intervento documentato.
E. Simon, Die Geburt der Aphrodite, Berlino 1959; L. Alscher, Götter vor Gericht, Berlino 1963, Passim; P. Zancani Montuoro, in Essays in Memory of Karl Lehmann, New York 1964, p. 386 ss.
Gesso patinato, 162x85 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Scalone (terzo piano)
La collocazione in alto a parete ha permesso una buona conservazione.
Nessun intervento documentato.
Marmo pario, h. 222x160 cm
Museo Archeologico, Atene
Gesso, h. 222x160 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
Fino al 2001: Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Palermo
Scalfito in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Marmo pario, h. 215 cm
Sala VIII, Museo Archeologico, Olimpia
Gesso, h. 233 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel 1912 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 2526, p. 92).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Santa Rosalia, Sala Ernesto Basile
1912(?) – 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Scalfito e reintegrato in diversi punti.
Reintegrato nel collo, nell’addome e nelle gambe da Salvatore Rizzuti tra il 2002 e il 2003 (?).
Marmo, h. 200 cm
Musei Capitolini, Roma
Gesso, h. 210 cm
L'opera fu realizzata prima del 1891 e donata ufficialmente al R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1896.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, sala Ernesto Basile
1891 - 1892: Esposizione Nazionale di Palermo (donato dal Municipio di Roma)
1892 - 1896: ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1896 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Villa San Cataldo, Bagheria, Palermo
Da gennaio 2005: Palazzo Fernandez, Paler
Figura emblematica che incarna gli ideali del linguaggio gotico e del classicismo arcaico della scultura italiana della seconda metà del Duecento, Arnolfo di Cambio (Colle Val d’Elsa 1240/45 ca – Firenze 1302/10), scultore e architetto, si formò al seguito di Nicola Pisano, collaborando al pulpito del Duomo di Siena (1264-67), e all’arca di San Domenico a Bologna (1265-69). Nei primi anni Settanta giunse a Roma, dove lavorò al servizio di Carlo d’Angiò probabilmente iniziando con lavori urbanistico-architettonici. Realizzò a partire dal 1277 capolavori assoluti come la Monumento a Carlo I d’Angiò per il tribunale di fianco all’Aracoeli (Musei Capitolini), chiesa di cui progetta le trasformazioni. Nel 1281 è impegnato a Perugia nella Fontana Minore, oggi smembrata (Perugia, Pinacoteca Nazionale) e poco dopo nel Monumento funebre del cardinal de Braye (Orvieto, San Domenico). Negli anni seguenti continua la sua carriera con altre opere fondamentali come i Cibori per San Paolo fuori le mura (1285) e Santa Cecilia in Trastevere (1293), il celeberrimo Presepe per Santa Maria Maggiore, il Monumento a Bonifacio VIII (1296) e la Statua in bronzo di San Pietro per la Basilica Vaticana (1300). Sul finire del ‘200 tornò a Firenze dove Vasari gli attribuisce la progettazione di Santa Maria del Fiore, Santa Croce, Santa Maria Novella e Palazzo della Signoria.
Il Monumento a Carlo I d’Angiò, conservato preso i Musei Capitolini di Roma, anticamente collocata probabilmente entro un’arcata polilobata, nella basilica di Santa Maria in Aracoeli, successivamente fu conservato nel Palazzo Senatorio. É considerata un’opera fondamentale, in cui Arnolfo rinnova la tradizione della ritrattistica classica romana in un linguaggio moderno, sensibile a una cultura che si può definire protoumanistica. Realizzata intorno al 1277, l’opera raffigura il sovrano seduto su un trono con protomi leonine, con in mano i simboli regali ben in vista (corona e scettro), in un atteggiamento di meastosa dignità, ma anche di realistica fisicità. L'opera è importante perché dopo gli pseudo-ritratti di Federico II risalenti alla prima metà del XIII secolo e dopo i primi ritratti per monumenti funebri (come quello di quello di Clemente IV di Pietro di Oderisio conservato nella chiesa di San Francesco di Viterbo), Arnolfo fu il primo in Europa a scolpire un ritratto realistico di un personaggio vivente nell'epoca post-classica. Particolarmente notevole è il volto, dove si concentrarono gli sforzi dello scultore per rendere il ritratto solenne ma anche verosimile, rappresentando dettagli fisici quali i solchi del viso.
L’opera presenta varie problematiche estetico visive quali parti mancanti: (l’indice della mano sinistra) e graffiata in molti punti, non presenta iscrizioni, presenta varie lesioni la più evidente è posta in corrispondenza del busto, la parte terminale del drappo risulta mancante. Presenta vari segni di danni antropici, su tutta la patinatura in zone sparse, nella mano destra manca il pastorale. Uno spesso strato di fuliggine ricopre in maniera evidente viso, veste e copricapo. Gli arti inferiori presentano zone di pulitura, dovute a restauri precedenti. Sono presenti tracce di resina in entrambe le mani, i piedi sono consumati dal degrado e da danni antropici.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori della storia dell'arte.
A. M. Romanini, Il ritratto gotico in Arnolfo di Cambio, in “Internationaler Kongress fuer Kunstgeschichte”, Vienna (4-10 settembre 1983), Vienna 1983, pp. 203-209; Arnolfo di Cambio: una rinascita nell’Umbria medievale, catalogo della mostra (Perugia-Orvieto 2005-2006) a cura di V. Garibaldi, B. Toscano, Cinisello Balsamo, Silvana, 2005, pp. 123-126; Carlo I d’Angiò. Re di Sicilia e senatore di Roma: il monumento onorario nel Campidoglio del Duecento, a cura di E.B. Di Gioia, C. Parisi Presicce, prefazione di U. Broccoli, Roma 2009.
Bronzo, h.160 cm
Museo Archeologico Nazionale, Napoli
Gesso, h.160 cm
Donato all'ex Casa dei Padri Teatini di Palermo da Francesco I nel 1827, dal 1867 rimane in custodia nell'ex Monastero della Martorana di Palermo. Dal 1886 al 2000 viene ubicato a Palazzo Fernandez, sede dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. In seguito, per cinque anni rimane alla Villa San Cataldo di Bagheria, e nel 2005 viene riportato a Palazzo Fernandez. (n. d'ordine 165, c.f.r. Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario dell'Istituto di Belle Arti di Palermo,pp.82).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
È un bronzo riferito a Donatello del 1471 attualmente ubicato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È menzionato per la prima volta in una lettera del 1471, in cui Diomede Carafa, Conte di Napoli, ringrazia Lorenzo il Magnifico per il dono scultoreo. Il bronzo venne collocato nel cortile di Palazzo Carafa.
Vasari, nella prima edizione delle Vite (1550) ne parla come di un reperto archeologico. Nella seconda edizione, del 1568 la attribuisce a Donatello. Dal Cinquecento all'Ottocento l'opera è stata considerata collocabile nel III secolo a. C. e probabilmente perché l'autore prese spunto proprio da uno studio di una testa di cavallo di epoca ellenistica; attualmente ne è stata ricostruita la storia. Si tratta di un monumento equestre che Donatello avrebbe iniziato per Alfonzo V d'Aragona, Re di Napoli dal 1442 al 1458. Nel 1453 stipularono un accordo di committenza. Gli era stato commissionato un lavoro simile al monumento padovano del Gattamelata, per la realizzazione del Portale di Castel Nuovo. Probabilmente fu Lorenzo de Medici a recuperare la scultura per inviarla a Diomede Carafa, massimo rappresentante della corte aragonese. (c.f.r. Mediateca Medicea, archivio digitale su Palazzo Medici Riccardi).
La bellissima testa è quella di un cavallo che nel tentativo di rimuovere il morso, si gira bruscamente verso sinistra. La tensione dei muscoli, le vene turgide, gli orecchi mobili, oblique e asimmetrici, le froge del naso dilatate, danno la percezione di un animale vitale impetuoso e recalcitrante. Il taglio del collo induce a pensare che la testa sia stata ricavata da un monumento più grande, concepito per essere visto da lontano e dal basso.
La riproduzione ottocentesca, realizzata in gesso, rivela il metodo esecutivo a tasselli poiché presenta il solco di un tassello orizzontale sul muso. L'opera è cava, unita da un perno in legno all'interno.
Il gesso è danneggiato e graffiato in vari punti. Parte della narice sinistra è mancante. Alla base è rovinato da scalfiture e tracce di vernice nera. Tra il 2009 ed il 2011 è stato sottoposto ad una pulitura (rimozione degli strati di deposito, come polvere o patine), da Sophie Bonetti insieme agli allievi del corso di restauro dei gessi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. (cfr. S. Rizzuti, Vicende della gipsoteca storica dell'Accademia di Belle Arti di Palermo dal 1972 al 2015, Palermo 2015).
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori della storia dell'arte. Questo gesso è un esempio anatomico ed assume grande valore didattico nello studio zoologico ai fini artistici.
Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario dell'Istituto di Belle Arti di Palermo, 2015; Salvatore Rizzuti, Vicende della gipsoteca storica dell'Accademia di Belle Arti di Palermo dal 1972 al 2015, Palermo 2015.
Mediateca Medicea, archivio digitale su Palazzo Medici Riccardi - www.palazzo-medici.it/mediateca
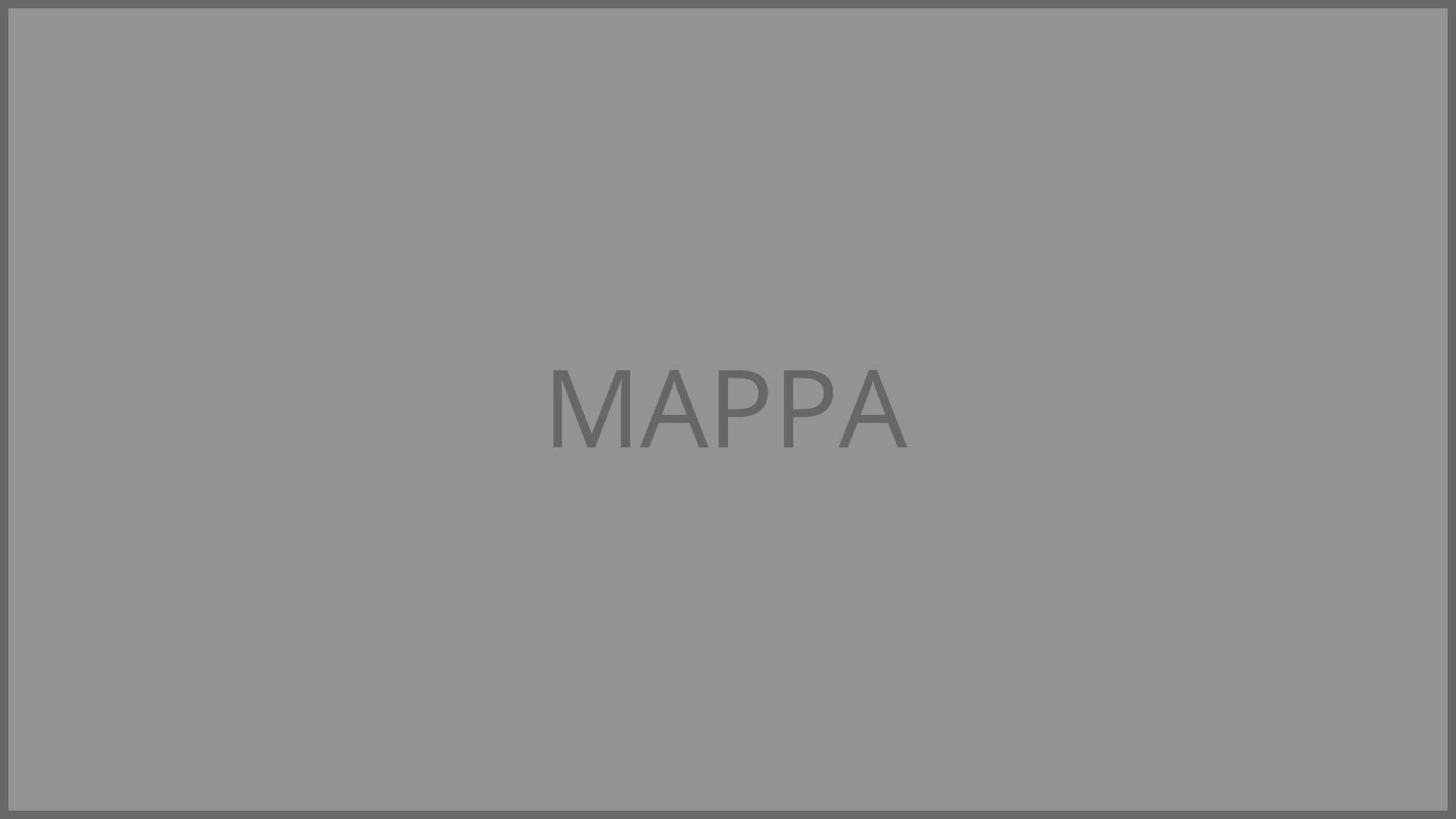
Marmo di Carrara, 85,5x82 cm
Museo Nazionale del Bargello, Firenze
Gesso patinato, d. 92 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel maggio del 1891 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’invetario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 818, p. 80).
Orazio Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Scalone (primo piano)
1891 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Vasari parlò di due opere «egregie e mirabili» riferendosi ai due tondi in marmo che Michelangelo «abbozzò e non finì» nel suo primo periodo fiorentino, accennando a un terzo appena incominciato. Entrambi gli altorilievi, datati dalla maggior parte della critica tra il 1503 e il 1505, rappresentano una Madonna con Bambino e san Giovannino, secondo un'iconografia tipica della devozione domestica fiorentina, sebbene il tondo scolpito rappresenti una soluzione meno consueta di quello dipinto. Il rilievo in oggetto fu commissionato da Bartolomeo di Silvestro di Roberto Pitti, Operaio di Santa Maria del Fiore, facendo dunque ipotizzare un collegamento con la commissione degli Apostoli per la cattedrale fiorentina. Verso la metà Cinquecento, ricordava Vasari, il tondo fu donato dal figlio Fra Miniato Pitti, «intendente e raro nella cosmografia et in molte scienzie e particolarmente nella pittura», all'amico Luigi Guicciardini. Nel 1823 il governo lorenese acquistò l'opera dall'antiquario Fedele Acciai per la Galleria degli Uffizi, dove rimase esposta accanto ai bassorilievi di Donatello e Luca della Robbia sino al 1873, quando passò al Bargello e fu collocata insieme a Bacco, David-Apollo e Bruto. Rispetto alla tradizione iconografica tardo-quattrocentesca, Michelangelo scelse di raffigurare la Madonna con il Bambino a figura intera. Lo scultore, poi, mostrò di prediligere la tipologia della Madonna dell'Umiltà nel collocare la Madonna su un basso sedile (secondo Acidini Luchinat forse un'allusione alla pietra angolare della Mater Ecclesia), come già fatto nella precedente Madonna della Scala. Il tema della lettura delle Sacre Scritture e dell'educazione di Cristo è evocato dal libro tenuto aperto da Maria su cui poggia il braccio scorciato dell'Infante, dettaglio che ha indotto a vedervi un riferimento al mistero dell'Incarnazione, ovvero alla parola letteralmente fatta carne (Barolsky 2003).
La solidità e monumentalità della figura materna appare fortemente debitrice dei rilievi antichi e specialmente della mediazione donatelliana, qualità felicemente coniugate con la tradizione fiorentina del XII e XIII secolo delle ancone dipinte. Altre reminiscenze del XV secolo sono poi visibili nell'acconciatura della Madonna e del san Giovannino e, soprattutto, nel nervoso grafismo delle linee del panneggio, quest'ultimo ispirato alla Prudenza di Jacopo della Quercia nella Fonte Gaia (Tolnay 1969, p. 160). Rispetto alla grazia quattrocentesca, invece, la monumentalità del capo della Vergine, che si staglia con decisione dal contorno del tondo e le forme solide dei dettagli del volto, gli occhi grande, le guance larghe e il mento, segnò la genesi di un nuovo tipo di bellezza femminile (Wölfflin 1952, pp. 43-44). Il dinamismo del gruppo della Vergine e Bambino, inoltre, si ritrova in analoghe composizioni di Leonardo, il cui cartone per la Sant'Anna esposto alla Santissima Annnunziata nel 1501, del resto, destò grande ammirazione tra gli artisti. Echi del tipo della Vergine del Tondo Pitti sono stati riscontrati in alcune elaborazioni grafiche di Raffaello, mentre lo stesso Michelangelo lo riprese nella Sibilla delfica della Sistina (Tolnay 1969, p. 161). Dopo la finitezza della Pietà e del David, Michelangelo tornò a lavorare le forme a scalpello come nella giovanile Battaglia dei Centauri, ottenendo quel caratteristico effetto di non finito che si coniuga a una perfetta traduzione dei passaggi chiaroscurali della coeva produzione grafica nella sottile trama tratteggiata. Lo stato incompiuto dell'opera, secondo alcuni unicamente dovuto alle circostanze materiali di interruzioni del lavoro (Hughes 1996, p. 435), è stato visto dalla critica come un'elaborazione in nuce di quel procedimento di liberazione della forma dalla 'prigione' della materia, che in quegli anni trovò pieno sviluppo nel San Matteo dell'Accademia.
Il gesso presenta consistenti cadute lungo il lato destro e parziali mancanze nel margine sinistro, nonché qualche lieve scalfitura superficiale, soprattutto in prossimità dei bordi, da cui si possono scorgere gli elementi in ferro dell’armatura.
Nessun intervento documentato.
Nel 1848 Ranalli fu il primo a riprodurre il tondo, riscoperto dalla critica insieme al compagno londinese soprattutto grazie ai festeggiamenti michelangioleschi del 1875. In quella occasione, nell'enfilade di copie in gesso che accompagnavano l'esposizione del David all'Accademia, infatti, figurava anche una riproduzione del Tondo Pitti realizzata da Ulisse Cambi, che segnò l'avvio di una notevole fortuna critica dell'opera, i cui calchi circolarono ampiamente nelle accademie e in edifici privati (Scheda n. 42, in Firenze 1994, p. 49).
H. Wölfflin, Classic Art. An Introduction to the Italian Renaissance, London: Phaidon, 1952 (ed. or. München 1899); C. de Tolnay, The Youth of Michelangelo, Princeton NJ: Princeton University Press, 1969, pp. 160-161; P. Barocchi, Michelangelo. Tondo Pitti, Apollo-David, Bruto, Firenze: Museo Nazionale del Bargello, 1982; C. Elam, A. Hughes, Michelangelo Buonarroti ad vocem, in The Dictionary of Art, 34 voll., a cura di J. Turner, London: Macmillan, 1996, XXI, pp. 431-436; P. Barolsky, The Meaning of Michelangelo's Pitti Tondo, in «Source. Notes in the History of Art», XXII, 2, 2003, pp. 10-12; C. Acidini Luchinat, Michelangelo scultore, Milano: Federico Motta, 2005, pp. 94-96, 302; I grandi bronzi del Battistero. L'arte di Vincenzo Danti discepolo di Michelangelo, catalogo della mostra (Firenze 2008), a cura di C. Davis, B. Paolozzi Strozzi, Firenze: Giunti, 2008.
Gesso, h. 135 cm
L’opera fu acquistata dal Reale Istituto di Belle Arti di Palermo nel luglio del 1892.
Fratelli Marchetti, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1892 - 1933(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1933(?) - 2004: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Da gennaio 2005: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta lievemente graffiata in diversi punti e ricoperta da depositi superficiali di polveri. Il braccio destro risulta lesionato.
Nel 2000 il Giuseppe Spatola la restaura al ginocchio. Nel gennaio del 2001 Salvatore Rizzuti la restaura nuovamente al ginocchio e ai deltoidi. Tra il 2009 e il 2011 Sophie Bonetti, in collaborazione con gli alunni del Corso di Restauro, ne effettuano la pulitura.
Bronzo dorato
Museo dell’Opera del Duomo, Firenze (già porta Nord, Battistero S. Giovanni, Firenze).
Gesso, h. 61 cm
(Sant’Ambrogio, San Marco, Tentazione nel deserto, Annunciazione, Gesù davanti a Pilato, Disputa nel tempio).
Si tratta di sei formelle, acquistate dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nell’agosto del 1892 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 907, p. 81).
Orazio Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1892 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme le formelle presentano diverse rotture lungo le cornici, svariati segni di sclafiture in diversi punti, e anche alcune rotture di parti anatomiche di alcune figure.
Nessun intervento documentato.
Bronzo, h. 285 cm
Duomo, Cappella di San Giovanni Battista, Siena
Gesso, h. 185 cm
Acquistato dall'istituto di Belle Arti nell'Agosto 1892 da Orazio Lelli. Dal 2005 al 2006 si sposta dalla Villa San Cataldo di Bagheria ai Mulini Virga. Nello stesso anno, in seguito a un restauro torna a Palazzo Fernandez, sede dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. (n. d'ordine 921, c.f.r. Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario dell'Istituto di Belle Arti di Palermo, p.82).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Sala E. De Maria Bergler
La scultura originale è un bronzo eseguito da Donatello tra il 1450 e il 1457.
Attualmente è custodita nella cappella dedicata al santo, all'interno del Duomo di Siena. (c.f.r. Alessandro Perronchi, “Donatello e il potere”, Cappelli/Il Portolano, Bologna/Firenze 1980 pp.245-260). La statua è stata realizzata a Firenze. Nel 1457 l'artista spostandosi a Siena la porta con se, incompiuta e smembrata. Nel 1466 Papa Pio II la depone nella cappella mediana della sagrestia del Duomo, allora in costruzione al fine di ospitare la reliquia di San Giovanni Battista: il braccio destro. Nel 1482 Alberto Aringhieri fa costruire una cappella appositamente dedicata al santo, ubicazione odierna della statua.
Si tratta di un bronzo alto 185 cm, ottenuto tramite la tecnica a tasselli. Il retro, lasciato quasi grezzo, dimostra che la statua era destinata ad essere collocata in un tabernacolo o contro una parete. (cfr. Pope-Hennessy 1993, p.228 cpv.2).
In principio l'artista aveva lasciato l'opera incompiuta, l'avambraccio destro era assente. Ludovico De' Vecchi provvide al restauro e al completamento dell'opera facendo aggiungere il pezzo mancante. L'immagine del santo non tradisce l'iconografia classica: in piedi, il volto emaciato, vestito di pelli, in mano ha una croce e una pergamena in cui si legge “Ecce Agnus Dei”. Iconograficamente può essere affiancato ad un'altra scultura di Donatello; “la Maddalena lignea”. Seppure la tecnica scultorea sia diversa, a un primo sguardo si notano proprio similitudini stilistiche. Le pelli di San Giovanni sono state realizzate analogamente alla folta chioma della Maddalena Andando più a fondo nel confronto tra le due opere si coglie un'analogia comportamentale nei tratti somatici del volto dei due santi che descrive la fatica della vita ascetica. (cfr. Pope-Hennessy, 1993, pp.278-279). Un altro possibile confronto si può effettuare tra il San Giovanni Battista senese e quello veneziano, del 1455, ubicato nella Chiesa dei Frari. Il soggetto assume la medesima postura, ognuno dei tratti iconografici distintivi si ripete. La differenza sostanziale sta nel metodo esecutivo, l'opera veneziana è realizzata in legno policromo che forse dona più morbidezza ai tratti spigolosi del volto ossuto del Santo. (cfr. Castelfranco 1963, p.165 figg. 161-162).
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo è stato realizzato, anch'esso come la scultura originale, con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, sul braccio destro all'altezza del gomito, e sulle gambe.
Il calco in gesso è cavo, probabilmente soggetto a patinatura, è scalfito in vari punti. In alcuni punti presenta una decoesione della patina originale. Presenta alcune parti mancanti: le dita della mano destra e la croce che avrebbe dovuto impugnare. La gamba destra e la pergamena presentano segni invasivi di colla, probabilmente appartenente a strati di scotch strappati via. Presenta tracce di sporco e di pittura color terra di Siena bruciata. Sul busto, in corrispondenza del braccio destro una traccia di sporco nera. Sul naso, tracce di resina e di sporco. Ai piedi del basamento si trova un'iscrizione; 921. Sul polpaccio sinistro è stato incollato il numero d'inventario.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero. Questo particolare gesso può essere preso a confronto per lo studio dei soggetti sacri della storia dell'arte e dei loro tratti iconografici distintivi.
A. Parronchi, Donatello e il potere, Bologna-Firenze 1980; G. Castelfranco, Donatello e i sommi dell'arte italiana, Milano 1963; Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario dell'Istituto di Belle Arti di Palermo, 1857); C. Avery, Donatello. Catalogo completo, Firenze 1991, n. 76, pp. 132-133; John Pope-Hennessy, Donatello, Milano 1993.
Bronzo
Altare Maggiore, Basilica di Sant’Antonio, Padova
Gesso, 54x22 cm
Acquistati dal R. Istituto di Belle Arti nel giugno del 1893 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 1035, p. 82).
Giuseppe Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1893 - 1934: Palazzo Fernandez, Palermo
1934 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme le formelle presentano diverse rotture lungo le cornici, svariati segni di sclafiture in diversi punti, e anche alcune rotture di parti anatomiche di alcune figure.
Nessun intervento documentato.
Marmo, d. 106.8 cm
Royal Accademy of Fine Arts, Londra
Gesso patinato, d. 110 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel novembre del 1887 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1882 al 1922, n. ordine 295, p. 76).
E. Pierotti, Milano
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Scalone (primo piano)
1887 - 1933: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Insieme al Tondo Pitti evocato da Vasari quali opere «egregie e mirabili», il rilievo in questione fu commissionato da Taddeo Taddei e rimase nella casa fiorentina della famiglia fino all'inizio del XIX secolo quando passò nella collezione di Jean-Baptiste Wicar a Roma. Grazie alla mediazione di Antonio Canova, nel 1822 Sir George Beaumont acquistò la scultura per poi donarla nel 1830 alla Royal Academy di Londra dove tutt'oggi si trova.
Michelangelo realizzò l'opera durante il primo periodo fiorentino, in prossimità del Tondo Doni (Uffizi) e del Tondo Pitti (Bargello). Rispetto a quest'ultimo, il soggetto della Madonna con Bambino e san Giovannino in questo rilievo fu sviluppato da Michelangelo in una chiave di maggiore tensione a prefigurazione della Passione di Cristo. Il marcato contrapposto del Bambino, che pure si trova in coevi esempi leonardeschi e signorelliani, come in un gesto di ritorsione, ha indotto parte della critica a pensare a leggervi la paura di fronte al proprio destino, a cui si accompagna l'atteggiamento ammonitore della Madonna (Smart 1967, pp. 840-841). Altri hanno invece sottolineato il volto sereno e giocoso del Cristo in realtà incuriosito dall'uccellino tra le mani del san Giovanni (Tolnay 1969, p. 162; Wilde 1953, p. 69). Del resto, né Vasari né la letteratura critica successiva notaro mai un Bambino 'spaventato' e versioni successive del tema, pure ispirate dai rilievi in marmo michelangioleschi, come la Madonna del cardellino di Raffaello, non ne colsero mai il senso tragico (Easton 1969). Del resto, anche Leonardo nel primo cartone della Sant'Anna avrebbe suggerito negli atteggiamenti sfuggenti dei personaggi il tentativo della Madonna di sottrarre il Figlio alla Passione, come si evince da lettera di un agente di Isabella d'Este, il quale non nascose peraltro la perplessità della Chiesa rispetto a tali iconografie (Acidini Luchinat 2005, p. 96). Il piccolo san Giovanni porta con sé i simboli del futuro romitaggio nel deserto e porge a Gesù un pettirosso o cardellino (simbolo della Crocifissione) e un oggetto rimasto allo stato di abbozzo, variamente identificato come una corona di spine (Larson 1991, p. 845) oppure un cartiglio recante la scritta "Ecce Agnus Dei" (Acidini Luchinat 2005, p. 96). Gli studi hanno ipotizzato una rielaborazione del rilievo non finito in una fase successiva, probabilmente coprendo il seno della Vergine, dettaglio che indurrebbe a pensare a un originario riferimento alla Madonna allattante, simbolo di carità (Seidel 2003).
La ripresa dei prototipi leonardeschi fu combinata da Michelangelo con evidenti riferimenti all'antico, come nella postura semisdraiata prona del Bambino ricorrente nel sarcofago di Medea di Berlino. Tale evocazione di modelli classici è qui inserita in uno schema compositivo rigidamente ortogonale, funzionale a ottenere un effetto di forte dinamismo impresso dal contrasto con le direttrici oblique (Panofsky 1975, pp. 238-239).
Il bordo irregolare, lo spessore variabile delle superfici, la fessurazione nel profilo della Vergine, alcuni pentimenti e il fondo abbozzato caratterizzano il rilievo londinese come un esempio di non-finito ancor più palese del tondo del Bargello. Michelangelo, infatti, sembra aver trattato la superficie del marmo come un foglio di carta sul quale tracciare un'idea compositiva. Questi elementi sono stati variamente ricondotti alla partenza da Firenze dell'artista, all'insoddisfazione dello scultore per la fessurazione del marmo oppure ancora a un risultato formale intenzionale. Un esame materiale dell'opera in occasione della sua pulitura nel 1991 ha rilevato sul verso le lettere 'L A' e la presenza di fori lasciati dai colpi di un strumento da taglio di un altro scultore o del mercante da cui l'artista acquistò il blocco di marmo, identificato nello scalpellino Lapo d'Antonio di Lapo, il quale potrebbe essere il responsabile per la sopraggiunta fessura nel volto della Vergine in corso d'opera (Larson 1991 e Hirst 2005).
Infine, raffronti stilistici con Leonardo, Raffaello e con le figure femminili della Sistina hanno fatto oscillare la datazione del Tondo Taddei tra il 1502 e il 1508, ma gli studiosi non sono ancora giunti a una determinazione conclusiva, propendendo comunque per una cronologia successiva al Tondo Pitti.
Nell’insieme ha una buona struttura. Si presenta scalfita in diversi punti, soprattutto in prossimità dei bordi, da cui si possono scorgere gli elementi in ferro dell’armatura.
Nessun intervento documentato.
Inizialmente esposto nella casa di Beaumont a Grosvenor Square, il tondo fu subito riprodotto da numerosi artisti, tra cui Wilkie e Constable, consolidando una fortuna critica che crebbe esponenzialmente nel corso del XIX secolo. Fatto tradurre da Beaumont in gesso per mano dell'allievo di Canova Antonio Sarti, nel corso del secolo furono tratti numerosi calchi, per esempio per il Fitzwilliam Museum di Cambridge (ante 1884) e il Victoria and Albert Museum di Londra (1902), tanto da lasciare sull'originale tracce del sapone e olio anneriti usati per facilitare la rimozione della forma in gesso (Larson 1991).
Smart, The Taddeo Taddei 'Madonna' and the National Gallery 'Entombment', in «Journal of the Royal Society of Arts», CXV, 5135, 1967, pp. 835-862; C. de Tolnay, The Youth of Michelangelo, Princeton NJ: Princeton University Press, 1969, pp. 162-163; R.W. Lightbown, Michelangelo's Great Tondo: Its Origins and Setting, in «Apollo», n.s., 83, 1969, pp. 22-31; J. Wilde, Michelangelo and Leonardo, in «The Burlington Magazine», XCV, 600, 1953, pp. 65-77; M. Easton, The Taddei Tondo: A Frightened Jesus?, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XXXII, 1969, pp. 391-393; E. Panofsky, Studi di iconologia. I temi umanistici nell'arte del Rinascimento, Torino: Einaudi, 1975 (ed. or. New York 1939); J. Larson, The Cleaning of Michelangelo's Taddei Tondo, in «The Burlington Magazine», CXXXIII, 1065, 1991, pp. 844-846; Michelangelo nell'Ottocento: Rodin e Michelangelo, catalogo della mostra (Firenze 1996), a cura di M.M. Lamberti, C. Riopelle, Milano: Charta, 1996; M. Seidel, "Ubera Matris". Stratificazioni semantiche di un simbolo, in Arte italiana del Medioevo e del Rinascimento, 2 voll., a cura di Id., Venezia: Marsilio, 2003, II, pp. 577-626; C. Acidini Luchinat, Michelangelo scultore, Milano: Federico Motta, 2005, pp. 96-98, 302; M. Hirst, The Marble for Mihelangelo's Taddei Tondo, in «The Burlington Magazine», CXLVII, 1229, 2005, pp. 548-549.
Bronzo dorato
Museo dell’Opera del Duomo, Firenze (già porta Nord, Battistero S. Giovanni, Firenze)
Gesso, h. 61 cm
Si tratta di sei formelle, acquistate dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nell’agosto del 1893 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 907, p. 81).
Giuseppe Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1893 - 1934: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme le formelle presentano diverse rotture lungo le cornici, svariati segni di sclafiture in diversi punti, e anche alcune rotture di parti anatomiche di alcune figure.
Nessun intervento documentato.
Marmo, 104x63 cm
Bassorilievo tratto dalla Cantoria, Museo dell’Opera del Duomo, Firenze
Gesso, 104x63 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nell’agosto del 1893 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 1042, p. 84).
Giuseppe Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Santa Rosalia, Scalone (primo piano)
1893 - 1934: Palazzo Fernandez, Palermo
1934 - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Manca il braccio destro del putto in primo piano e l’angolo in alto a destra. Sulla superficie si segnalano diverse scalfiture e tracce di patinatura.
Nessun intervento documentato.
Marmo bianco di Carrara, h. 486 cm (la sola figura)
Galleria dell’Accademia, Firenze
Gesso, h. 133 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nell’agosto del 1896 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’invetario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 1213 p. 84).
Orazio Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti
1896 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Celebrato da Vasari come l'opera che «ha tolto il grido a tutte le statue moderne et antiche, o greche, o latine che elle si fussero», il David fu realizzato da Michelangelo su commissione dell'Opera del Duomo datata 16 gennaio 1501, intervenendo su un colossale blocco di marmo denominato 'il gigante', già parzialmente lavorato da Agostino di Duccio (1464) e Bernardo Rossellino (1476) ma abbandonato per la cattiva qualità e fragilità (la superficie era infatti rovinata da venature e cavità). Il David fu mostrato ai fiorentini in fase di ultimazione il 23 giugno 1503 e Michelangelo lo portò a compimento entro il marzo 1504, mentre fu ufficialmente svelato l'8 settembre 1504. Sebbene la committenza fosse legata al Duomo, la destinazione della statua in piazza della Signoria fu decisa da una commissione formata dai massimi artisti allora attivi a Firenze e, allorché giunse nel luogo prescelto, Michelangelo completò il David con lumeggiature dorate alla fionda e al tronco su cui poggia la gamba destra.
Contrariamente alla tradizione iconografica di David adolescenti e pastori, a cui si ascrivevano pure i precedenti di Verrocchio e Donatello, l'artista privilegiò una rappresentazione del figlio di Jesse privo di connotazioni legate alla narrazione biblica, realizzando un nudo virile adulto espressione dell'ideale classico di eroe guerriero. Michelangelo, inoltre, scelse di ritrarlo non nel più consueto momento di celebrazione della vittoria ma nel punto di massima tensione, in cui David, dopo aver incrociato lo sguardo di Golia, si concentra sullo sforzo necessario a compiere la torsione per lanciare la pietra. Lo scultore quindi tornava a sviluppare il tema del nudo dopo la Battaglia dei Centauri e, quantunque nella finitezza dell'atletica figura non vi sia traccia del 'non finito' proprio delle opere della maturità, l'analisi tecnica condotta nel 2003 ha permesso di apprezzare quella sottile varietà nel trattamento delle superfici che costituisce la cifra stilistica dell'artista. Colto nel 'prendere le misure' per colpire l'avversario, il David michelangiolesco sarebbe in questo senso un analogo dell'attività dello scultore, come del resto suggerito dal celebre verso dello stesso Michelangelo "Dauitte cholla fromba et io cho-ll'arco" vergato sul disegno del Louvre (DAG inv. 714). Già colpita da un fulmine nel 1512 e mutilata nel corso dei sollevamenti che portarono alla cacciata dei Medici nel 1527, nonché danneggiata dalla secolare esposizione agli elementi naturali, dopo alcuni trattamenti di restauro in situ a inizio Ottocento, si decise di portare la statua all'Accademia nel 1873 dove tutt'oggi è collocata.
Nell’insieme ha una buona struttura. La superficie si presenta scalfita in svariate parti. Risulta lacunosa parte della spalla sinistra.
Nessun intervento documentato.
Sebbene la sua fama fosse già consolidata nella letteratura artistica del XVI secolo, la consacrazione del David a icona nella modernità avvenne a partire nel XIX secolo, quando, dopo il trasferimento alla Galleria dell'Accademia, fu posta al centro dei festeggiamenti per il quarto centenario michelangiolesco del 1875. Nell'intento di costituire un "Museo Michelangelo", sul modello di quello dedicato a Thorvaldsen di Copenhagen, il David fu esposto accanto a fotografie, disegni e calchi in gesso delle opere custodite a Roma e Firenze, tra i quali il Mosé, le allegorie della Sagrestia Nuova, le Pietà di San Pietro e Rondanini, i due Schiavi del Louvre, offrendo ad artisti e visitatori un panorama completo della produzione dello scultore, non senza sollecitare una riflessione sulla differenza tra calco e originale (Firenze 1994, p. 18). Non a caso, come rimarcato da Fergonzi, a seguito della mostra ci fu una crescente richiesta di immagini fotografiche dei gessi, probabilmente perché questi mettevano meglio in evidenza gli aspetti compositivi del linguaffio michelangiolesco rispetto all'originale. Sul modello fiorentino, l'Ecole des Beaux-Arts parigina nel 1876 inaugurò un museo delle copie michelangiolesche esponendo, oltre alla propria collezione realizzata dall'Atelier des Moulages, anche una nuova serie richiesta a Firenze nella cornice scenografica della Cappella di Margherita di Valois (Firenze 1996, pp. 122-124). Fu così che dopo il primo calco di Clemente Papi (1847) numerose furono le copie in gesso che andarono ad arricchire le collezioni di modelli delle Accademie di tutta Europa e d'Oltreoceano. Nel 1873, anno in cui il David fu portato in processione trionfale all'Accademia, sul piazzale intitolato a Michelangelo veniva collocata una copia in bronzo nuovamente di Papi, mentre nel 1910 la replica in marmo di Luigi Arringhetti fu posta sul luogo originario in cui la statua sorgeva in piazza della Signoria. Le copie in gesso nell'allestimento dell'Accademia fiorentina, invece, furono rimosse da Corrado Ricci nel 1909, lasciando spazio agli originali quattro Prigioni, il San Matteo e la Pietà di Palestrina.
Michelangelo nell'Ottocento: il centenario del 1875, catalogo della mostra (Firenze 1994), a cura di S. Corsi, Milano: Charta, 1994; Michelangelo nell'Ottocento: Rodin e Michelangelo, catalogo della mostra (Firenze 1996), a cura di M.M. Lamberti, C. Riopelle, Milano: Charta, 1996; C. Acidini Luchinat, Michelangelo scultore, Milano: Federico Motta, 2005, pp. 70-83, 301-302; F. Petrucci, La scultura di Michelangelo nei gessi dell'Accademia, in L'immortalità di un mito: l'eredità di Michelangelo nelle arti e negli insegnamenti accademici a Firenze dal Cinquecento alla contemporaneità, catalogo della mostra (Firenze 2014), a cura di S. Bellesi, F. Petrucci, Firenze: Edifir, 2014, pp. 106-112; Der Göttliche. Hommage an Michelangelo, catalogo della mostra (Bonn 2015), a cura di G. Satzinger, München: Hirmer, 2015.
Marmo, 150x155 cm
Chiesa di San Lorenzo, Sagrestia Nuova, Firenze
Gesso, 130x197 cm
Acquistata dal Reale Istituto di Belle Arti di Palermo nel giugno del 1917.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, sala Mario Rutelli
1917 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
La Notte è una scultura in marmo di Michelangelo Buonarroti, databile al 1526-1531 e fa parte della decorazione della Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze. In particolare è una delle quattro allegorie delle Parti della Giornata, e si trova a sinistra sul sarcofago della tomba di Giuliano de' Medici duca di Nemours. La Notte fu tra le prime sculture ad essere conclusa e gode di una straordinaria fama grazie anche a una nota quartina di elogio di Carlo Strozzi, in cui la statua veniva invitata a svegliarsi per farsi vedere animata. Fonti antiche (Doni) dicono che il maestro dovette rifare il braccio sinistro della statua due volte, a causa di un danneggiamento.
La Notte è rappresentata come una personificazione femminile, semidistesa e nuda, come le altre statue della serie. La posizione sdraiata, con la gamba sinistra piegata, la testa reclinata, ricordano da vicino la Leda e il cigno di un perduto cartone michelangiolesco del 1530 circa. Il braccio sinistro sta piegato dietro la schiena e quello destro regge la testa appoggiandosi alla coscia sinistra. Ciò provoca una torsione che ruota il busto in favore dello spettatore. I capelli sono lunghi, raccolti in trecce e in testa indossa un diadema col crescente e una stella. Tra le varie letture iconologiche proposte, si è vista la statua come emblema dell'Aria o dell'Acqua, del temperamento flemmatico della teoria umorale, della fecondità della notte. Le allegorie del Giorno e della Notte, come quelle dell'Aurora e del Crepuscolo, sono concepite come immagini della forza distruttrice del tempo. La Notte, circondata da simboli del buio e del sonno, si mostra levigatissima, riflettendo la luce con autentici bagliori lunari. La statua del Giorno fu lasciata scabra e appositamente non finita (soprattutto nel volto, che sembra non ancora completamente riemerso dal sonno) in modo che la luce si rapprenda sulla superficie. Michelangelo sfoggia in questa scultura la sua piena maturità artistica con una posa plastica ripresa forse da un cartone, La Leda e il Cigno da lui dipinto in precedenza e poi andato perduto di cui esistono solo copie. Colpisce come in quasi tutte le sue sculture, la gigantesca maestosità manierista della muscolatura del soggetto, la perfezione dei particolari anatomici trasferiti in una struttura sicuramente inconsueta in qualsiasi modella del tempo, eppure così aggraziata, proporzionata, anatomicamente funzionale nonostante sia una interpretazione personalissima del corpo femminile. Risaltano le clavicole, le pieghe dell’addome, la possanza mascolina delle spalle in contrasto con la sfrontatezza dei capezzoli, modellati nel marmo con una morbidezza palpabile che li rende nonostante la durezza del materiale impiegato, carnosi e ispiratrici di una prova tattile per sondarne l’effettiva sensuale consistenza. Dai seni turgidi e sodi, le cosce marmoree ma piene di vita e calore su cui appoggia il suo gomito perfetto, “La Notte” riposa, crucciata, con il volto stranamente impersonale, i lineamenti canonici di dea, così classici e inusuali nelle sue opere, non approfonditi da una indagine psicologica fisiognomica caratterizzante. È forse la più bella e definita rispetto alle altre statue guardiane dei sarcofagi, l’unica a mostrare oggetti simbolo del suo stato di divinità notturna come contorno del giaciglio cui è posta: la civetta, la maschera, un mazzo di fiori. Michelangelo che non si prodiga nella ricercatezza barocca dello scolpito nella chioma, si esalta invece nella plasticità degli arti, fino alla sublime prova di eccelso scultore nella particolareggiata, scomposta e vitale rifinitura delle dita dei piedi, facendone uno dei punti focali della composizione, riuscendo così a mantenere costante l’attenzione dello spettatore verso la totalità dell’opera.
La tecnica utilizzata per la realizzazione della copia in gesso è quella della cosiddetta formatura a tasselli. Di fatti, si intravedono chiaramente i segni di giuntura dei tasselli. Rispetto all’originale, notiamo la mancanza di alcune porzioni di materia, in particolare il naso della civetta, i capezzoli della figura femminile, l’alluce del piede sinistro, dovuti probabilmente ai trasporti del gesso nel tempo.
L’opera è stata oggetto di un recente intervento di restauro, nel quale è stata operata la pulitura della patina per tutta la superficie dell’opera. Attualmente si riscontrano in varie parti, lungo il busto della figura, tracce di colature eterogenee di sostanze non pertinenti.
Sin dalla nascita delle principali accademie di belle arti in Italia, la figura di Michelangelo è sempre stata al centro della didattica formativa degli artisti. Non è un caso che quasi tutte le gipsoteche italiane conservano copie dei capolavori del maestro fiorentino. Opere come il David, le allegorie del giorno e della notte, la Pietà ecc, figurano ad esempio nelle gipsoteche di Carrara, Napoli, Palermo, ecc. Uno degli aspetti principali della formazione artistica degli allievi delle accademie, sin dai primi del XIX secolo, era indubbiamente quello dell’esercitazione attraverso il disegno dal vero sui modelli dell’arte rinascimentale. Il valore didattico-formativo basato sul disegno rimane ancora oggi fondamentale per gli insegnamenti specifici dei piani formativi delle accademie, svolgendo la duplice funzione di modello iconografico e al contempo di simbolo delle tecniche tradizionali di natura accademica.
Baldini, Michelangelo scultore, Milano, Rizzoli, 1973; A. Grömling, Michelangelo Buonarroti: vita e opere, Köln, Könemann, 2000; M. AlvarezGonzáles, Michelangelo, Milano,Mondadori Arte, Milano 2007.
Gesso patinato, h. 117 cm
Il calco collocato inizialmente a Palazzo Fernandez, è stato spostato a Palazzo Santa Rosalia nel 1933 dove è rimasto fino al 2000. Successivamente è stato trasferito presso i locali degli ex Mulini Virga (oggi sede di un istituto scolastico) per poi ritornare a Palazzo Fernandez dove è attualmente custodito. La figura risulta scalfita in molti punti e mancano le mani.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
Fino al 1933(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1993 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Da gennaio 2005: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme ha una buona struttura. Si presenta scalfita in diversi punti. Risulta ricoperta da depositi superficiali e incrostazioni. Manca di entrambe le mani. Nella parte posteriore vi sono delle scritte, dovute ad atti vandalici.
Nessun intervento documentato.
Martella, T. (tesi di laurea di), Storia della Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Palermo - dalle sue origini ad oggi, A. A. 2000/2001; Rizzuti, S. (a cura di), Vicende della Gipsoteca storica dell’Accademia di Belle Arti di Palermo dal 1972 al 2015.
Marmo
Cattedrale di Palermo
Gesso, Acquasantiera h. 275 cm, mensola h. 45 cm
Probabilmente la copia in gesso dell’acquasantiera fu realizzata in occasione dell’Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-1892.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
Fino al 1933(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1993(?) - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme ha una buona struttura. Si presenta scalfita in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Marmo h. 273 cm
Museo Regionale di Messina (già Fontana del Nettuno, Messina)
Gesso, h. 273 cm
Donato al R. Istituto delle Belle Arti Palermo, dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1896.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Santa Rosalia, Atrio
1891 – 1892: Esposizione Nazionale di Palermo
1892 – 1896(?): Ex Casa dei Padri Filippini, Palermo
1896(?) - 1934 (?): Palazzo Fernandez, Palermo
1934(?) - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Nel 1547, ultimati i lavori a Genova, il Montorsoli tornò a Roma, e qui trovò modo di mettersi in contatto con i rappresentanti del Senato messinese, venuti alla ricerca di un artista per la fontana celebrativa del nuovo acquedotto, che convogliava nella città le acque del Camaro. Montorsoli seppe cogliere l'occasione, e nel settembre dello stesso anno era già in Messina, ove iniziava un fervido decennio di attività (1547-1557), durante il quale, sulla base delle sue ormai maturate e complesse esperienze, realizzò alcune delle sue opere più alte; decennio di attività che fortemente incise sulla cultura locali, cambiandone l'orientamento in senso rinascimentale, ed ebbe anche un seguito in tutto l'ambiente siciliano. L'opera alla quale subito si applicò fu la grande fontana di Orione sistemata nella piazza del duomo, che lo tenne impegnato dal 1547 al 1551. Dopo la nota fontana di Orione, realizzò la fontana del Nettuno, anch’essa voluta dal senato cittadino.
La fontana del Nettuno fu completata nel 1557e originariamente collocata di fronte alla Palazzata sulle banchine del porto, nei pressi del Municipio, con le spalle rivolte al mare, per simboleggiare il dio Nettuno che offre la ricchezza del suo mare alla città. Secondo altra tradizione popolare, legata alla storia di “lu Gialanti Pisci”, per sbeffeggiare le popolazioni calabresi, a cui volgeva le spalle. Nel 1757 fu posta su un lato la statua di Carlo III di Borbone- opera di Giuseppe Buceti - e, nel 1832, fu aggiunta la statua di Francesco I - opera dei messinesi fratelli Subba. Queste ultime sculture in bronzo furono poi fuse, per farne proiettili, durante la rivoluzione del 1848. Durante quel medesimo anno, in conseguenza dei bombardamenti borbonici, furono danneggiati il Nettuno e la Scilla. La statua di Scilla, danneggiata dai colpi di cannone, venne sostituita da una copia eseguita daLetterio Subba nel 1858; l’originale rimane custodita nelMuseo regionale di Messina, così come già il Nettuno, la cui copia ottocentesca è una eccellente riproduzione di Gregorio Zappalà, completata appena due anni prima, nel 1856. L'originale della statua del Nettuno rimase sino al 1908 all’interno della chiesa di S. Maria degli Alemanni e, successivamente, spostata presso il Museo Regionale di Messina, dove ancora è custodita. Al contrario della fontana di Orione, che venne danneggiata dal terremoto, il complesso del Nettuno rimase pressoché integro. Nel 1934 la fontana fu trasferita nell’attuale sito, in piazza Unità d’Italia, per volere dell’allora prefetto Michele Adinolfi a ornamento della piazza antistante il palazzo della Prefettura, e ruotata di 180 gradi rispetto al verso originario cosicché oggi è rivolta verso il mare. Opportuno appare evidenziare che la fontana del Nettuno era perfettamente allineata con le altre due opere importanti realizzate dal Montorsoli: la fontana di Orione e laLanterna di San Ranieri (il faro del porto).
Il braccio destro è spezzato e scalfito in molti punti, presenta vari segni di natura antropica. Nel 2001 furono attuati interventi di ricostruzione, curati da Salvatore Rizzuti, dove vengono effettuati interventi su base e piedi del complesso in gesso, interventi precedenti al lavoro di Rizzuti, vedono l’opera ritoccata in più punti, dove sono visibili sulle cosce, sul braccio destro, e sulla mano sinistra, purtroppo non documentati.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori della storia dell'arte, in questo caso la ricezione del gusto rinascimentale di matrice michelangiolesca in Sicilia.
G. Vasari, Le Vite... con nuove annotaz. e commenti di G. Milanesi, VI ,Firenze 1881, pp. 629-660; M. Buonarroti, Le Lettere... a cura di G. Milanesi, Firenze 1875, passim; G. P. Lomazzo, Trattato dell'Arte della pittura, scultura ed architettura, Roma 1844, III, p. 217; R. Borghini, Il Riposo, Firenze 1584, pp. 163, 495-498; F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno.... VI, Firenze 1820, pp. 221-246; J. Doria, La chiesa di San Matteo in Genova, Genova 1860, pp. 10-14; G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI. Memorie storiche e documenti, I, Palermo 1880, pp. 761, 769-780; II, ibid. 1883, p. 288; S. Bottari, G. A. Montorsoli a Messina, in L'Arte, XXXI(1928), pp. 234-244; A. Venturi, Storia dell'Arte italiana, X, 2, Milano 1936, pp. 88, 107-153 (con bibl.); A. M. Gabrielli, Su B. Ammannati, in La Critica d'arte, II (1937), p. 89; F. Basile, Studi sull'architettura di Sicilia - La corrente michelangiolesca, Roma 1942, pp. 35-56; S. Boscarino, L'opera di Giovanni Angelo Montorsoli a Messina, Roma 1957 (con larghi riferimenti bibl.); C. Manara, Montorsoli e la sua opera genovese, Genova, 1959 (con bibl.); M. G. Ciardi Dupré, La prima attività dell'Ammannati scultore, in Paragone (1961), n. 135, pp. 3-28.
Bronzo, h. 151 cm
Sala XIX, Museo Interdisciplinare Regionale “A.Pepoli”, Trapani
Gesso, h. 151 cm
Donato al R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1896.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1891 - 1892: Esposizione Nazionale di Palermo
1892 - 1896(?): Ex Casa dei Padri Filippini, Palermo
1896(?) - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 – 2004: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta lievemente graffiata in diversi punti e ricoperta da depositi superficiali di polveri. Il braccio destro risulta lesionato.
Tra il 1995 e il 1996, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti effettua diversi interventi strutturali nella base, nel capitello e negli angeli.
I.Bruno, scheda n. III.1, (Annibale Scudaniglio, Leggio) in Il Tesoro Nascosto. Gioie e argenti per la Madonna di Trapani, catalogo della mostra (Trapani, Museo Regionale Pepoli, 2 dicembre-3 marzo 1996) a cura di M.C. Di Natale, V. Abbate, Palermo, Novecento, 1995, pp. 241-244.
Stucco
Oratorio del Rosario in San Domenico, Palermo
Gesso
a) h. 63 cm; b) h. 73 cm
Acquistati dal R. Istituto di Belle Arti nel maggio del 1890 (v. Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. d'ordine 689-90, p. 79).
Gioacchino Brocia
a) Accademia di belle Arti di Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, Galleria Bianca
b) Accademia di belle Arti di Palermo, Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1890 - 1933(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1933(?) - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
a) Lacunosa, segni di scalfiture in diversi punti.
b) Scalfita in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Marmo, h. 72 cm
Museo Nazionale del Bargello, Firenze
Gesso, h. 67 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti nell'agosto del 1892 (Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. d'ordine 917, p. 82).
Orazio Lelli, Firenze
Accademia di Belle Arti di Palermo - Cantieri Culturali alla Zisa, Galleria Bianca, Palermo
1892 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Il busto di Costanza Bonarelli è un'opera di Gian Lorenzo Bernini, eseguita tra il 1636 e il 1638 circa. Il ritratto è realizzato in marmo ed è conservato nel Museo nazionale del Bargello a Firenze. Il busto proviene dalla Galleria degli Uffizi, dove era esposto fin dal 1645 nel primo corridoio accanto al busto di Bruto di Michelangelo Buonarroti.
Costanza Bonarelli o Bonucelli era figlia di uno stalliere e moglie di Matteo Bonarelli, uno scultore, allievo del Bernini. Secondo recenti studi proveniva da una famiglia legata al ramo viterbese dei Piccolomini. Era una donna dall'animo imprenditoriale: aiutava suo marito in bottega, occupandosi delle vendite e dei clienti. Secondo la biografia scritta da Domenico Bernini, figlio di Gian Lorenzo, la donna era amante del padre e un documento anonimo sostiene che anche il fratello dello scultore, Luigi, frequentasse la donna. Una mattina, prima dell'alba, Gian Lorenzo chiese di preparare la carrozza perché voleva andare in campagna; invece si diresse verso la zona di San Pietro, dove aveva lo studio, e dove proprio di fronte abitava la donna. All'alba dalla casa di Costanza uscì il fratello Luigi, accompagnato alla porta dalla donna che ancora aveva i capelli in disordine. Accecato dalla gelosia, Gian Lorenzo, seguì il fratello e dopo averlo raggiunto proprio all'ingresso di San Pietro iniziò a bastonarlo con un asse di ferro, sino a rompergli due costole. Luigi fu salvato da alcuni passanti che frenarono l'ira di Gian Lorenzo. L'artista tornato a casa diede poi ordine al proprio servo di sfregiare l'amata in segno di punizione. Di conseguenza il servo fu esiliato, Luigi partì per Bologna e Bernini, grazie all'intervento diretto del Papa Urbano VIII (richiesto dalla madre dei Bernini), fu punito solamente da un'ammenda pecuniaria. Il busto giunse a Firenze nel 1645, probabilmente come dono al cardinale Giovan Carlo de' Medici.
Resta una vera eccezione nell'intera produzione ritrattistica del Bernini. Un vero atto d'amore. Ritrae la donna come sarebbe apparsa nell'intimità quotidiana, con i capelli spettinati e la camicia aperta sul seno: lo sguardo è fiero, leggermente sorpreso, e le labbra carnose appena dischiuse. Il collo è robusto, i capelli sono lievemente scomposti, gettati indietro per dar luce all'ampia fronte, e l'acconciatura allentata di trecce raccolte dietro la nuca della donna, colgono la donna in un'acuta indagine introspettiva. La veste è leggera e presenta un semplice nastro che segue la scollatura aperta sino a far intravedere il seno.
La straordinaria vivezza, rintracciabile solo nel busto del cardinale Scipione Borghese (1632), può essere prova del particolare sentimento che legava l'artista alla donna.
Le superfici risultano gradevoli, levigate soprattutto sul viso e sul collo, mantenendo tale piacevolezza anche sulle ciocche di capelli arricciate e sulle pieghe della veste.
Il calco ottocentesco, proveniente da Firenze, su esecuzione del formatore Orazio Lelli, giunse a Palermo nel 1892, rimanendo custodito nelle collezioni dell'Accademia di Belle Arti.
Il calco in gesso è cavo, come purtroppo si evince dalle pesanti lacune dovute alla rottura in più pezzi avvenuta nel 1997.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero.
Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. d'ordine 917, p. 82; M. Fagiolo Dell'Arco, Berniniana: novità sul regista del barocco, in Biblioteca d'arte Skira, vol.7, Skira, 2002, pp.247; T. Montanari, Gian Lorenzo Bernini, Roma 2004, pp. 122-123.
Stucco, h. 228 cm
Oratorio del Rosario in San Domenico, Palermo
Gesso
a) h. 228 cm; b) h. 185 cm
Acquistato, assieme ad una seconda copia, oggi acefala, dal R. Istituto di Belle Arti nel febbraio del 1914 (v. Giornale dell'entrata e dell'uscita degli oggetti mobili dell'inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. d'ordine 2675-78, pp. 91-92).
a) Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, sala Mario Rutelli
b) Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, sala Salvatore Valenti
a)
1914 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Villa San Cataldo, Bagheria
b)
1914 - 1934(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1934(?) - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
a) Manca il braccio sinistro e il tronco a cui si appoggia. Scalfita in alcuni punti.
b) Manca la testa e la mano sinistra. Scalfita in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Marmo, h. 175 cm
Museo dell’Hermitage, San Pietroburgo
Gesso, h.175 cm
Museo Canova, Possagno
Gesso, h. 175 cm
La copia fu donata al Museo dell’Università di Palermo da Finocchiaro nel 1826.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1827 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: Ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Eseguita su commissione da Giuseppina Beauharnais Bonaparte nel 1802 quando si trovava a Roma, passando dopo la sua morte, nel 1815, nelle raccolte di Alessandro I di Russia. Il modello era stato terminato nel 1806 mentre il marmo fu completato nel 1811-1812. A febbraio nel 1812 fu esposto al Salon di Parigi con gran successo. Quatremère de Quincy rilevò la novità dell'invenzione, che non compare nella statuaria antica se non nei piccoli rilievi. L'opera originale, conservata al Museo Hermitage di San Pietroburgo, insieme alla Danzatrice col dito al mento (1809, marmo, Torino, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli) e alla Danzatrice con cembali (1809-1814, marmo, Staatliche Museen, Berlino) influenzò la danza dell'Ottocento. Il soggetto è una danzatrice, “Musa della Danza”, nello specifico “Erato, musa della danza amorosa”, come è nominata nella lettera a Quatremère dal Canova, il quale aveva pensato di accompagnarla con il suono di un flauto (lettera al Bossi del 27 Novembre 1807 in Tosi 1940). Come noto presso la Gipsoteca di Possagno si conserva il gesso originale dell’opera. Fin dal 1832, anno della consacrazione del Tempio di Possagno, Monsignor Sartori incaricò il professore di architettura all’Accademia di Belle Arti di Venezia Francesco Lazzari (1791-1871) perché progettasse la costruzione della "raccolta dei gessi". La nuova fabbrica della Gipsoteca fu completata nel 1836. Lazzari aveva edificato una grande basilica, un vero e proprio mausoleo per l'arte del grande Antonio Canova: “un Olimpo per la scultura”. L’edificio si presenta con un'alta e solenne volta a botte con cassettoni, divisa in tre settori; Nei settori di destra sono disposti i modelli di Dedalo e Icaro, la Danzatrice con le mani sui fianchi, le due sculture di Venere ed Ebe, la Pietà, la Pace e il modello per il Papa Pio VI. Nel 1917, durante la prima Guerra Mondiale, una granata colpì la Gipsoteca: alcuni gessi furono completamente distrutti, decine furono lesionati, scheggiati. Una grandiosa opera di restauro di Stefano e Siro Serafin, padre e figlio, consentirono di far rinascere la Gipsoteca: il portone del museo fu riaperto ai visitatori nel 1922. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per prevenire nuovi bombardamenti, la Gipsoteca fu in parte svuotata, le statue furono trasferite e depositate all’interno del Tempio di Possagno, dove rimasero fino al 1946 quando ritornarono nella loro collocazione originale. La Gipsoteca fu riallestita nel 1957 da Carlo Scarpa, che provvide anche alla sistemazione del Monumento di Maria Cristina d’Austria e all’allestimento dello spazio da lui progettato.
Il soggetto delle danzatrici fu più volte affrontato da Canova (Berlino, Staatliche Museen; Torino, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli; San Pietroburgo, Hermitage) sperimentando ogni volta nuove pose e diversi ritmi compositivi nel tentativo di risolvere il rapporto fra corpo e panneggio. Nella poetica canoviana, infatti, il corpo, sublimato nello slancio e nel ritmo, diventa strumento che aspira alla bellezza ideale. D'ispirazione per queste creazioni furono le pitture e i rilievi classici con scene di menadi e baccanti. Le Danzatrici trasmettevano, evidentemente, positività, forza, giovinezza e ammaliavano non solo Canova. Tant’è che l’artista fu costretto a farne diverse repliche e molte altre vennero realizzate negli anni successivi, issate a trasmettere bellezza e grazia in luoghi, i più diversi, dalla Stazione Centrale dei Telefoni di San Pietroburgo sino al Messico o a Cuba o al Canada. La nostra Danzatrice voluta da Giuseppina Buonaparte venne acquistata da Alessandro I di Russia e giunse a San Pietroburgo proprio nei più tragici momenti del 1818, trovando poi collocazione definitiva e inamovibile nel nuovo Hermitage. Va chiarito che il tema della danza in scultura non venne limitato da Canova alle tre Danzatrici. Egli rappresentò infatti altre figure che danzano, ma si trattava di dee o muse, quindi figure mitologiche, concettualmente ben diverse da queste, ragazze reali, impegnate in danze contemporanee, lontanissime dalle pur superbe rappresentazione di Ebe o di Tersicore.
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo è stato realizzato, anch'esso come la scultura originale, con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, presenti in varie zone della superficie.
Nell’insieme la struttura si presenta in buono stato di conservazione. La superficie risulta scalfita e graffiata in diversi punti, ricoperta da incrostazioni e sporco superficiale. Presenta delle lesioni nei polsi e nella parte superiore delle braccia. Non si registrano Interventi di restauro documentati.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero.
Inventari oggetti di antichità della Regia Università, 1857, Fondo Archivio Storico dell’Università degli Studi di Palermo, Archivio Storico dell’Università di Palermo, Palazzo Steri; Tosi, L’amicizia del Canova per il Bossi alla luce di nuove lettere, Venezia 1940; G. Delfini Filippi,La Gipsoteca nel XX secolo. Note d’archivio, in Antonio Canova, Venezia 1992, pp. 369-375; M. Guderzo, La bellezza violata: i danni della grande guerra sulle opere del Canova, Possagno 2004; G. Delfini Filippi,“Allo scopo di impedire saccheggio e devastazione”: i provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio canoviano a Possagno nei giorni della Grande Guerra, in La memoria della prima guerra mondiale: il patrimonio storico-artistico tra tutela e valorizzazione, Vicenza 2008, pp. 159- 171; Canova e la danza, catalogo della mostra (Possagno, Museo e Gipsoteca Antonio Canova, 3 marzo - 30 settembre 2012) a cura di M. Guderzo, Crocetta del Montello 2012.
Marmo, h. 235 cm
Musei Vaticani, Città del Vaticano, Roma
Gesso, h. 235 cm
Museo Canova, Possagno
Gesso, h. 250 cm
La copia fu donata al Museo della Reale Università di Palermo dal Finocchiaro nel 1826.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, I piano, Aula Ex Direzione
1827 - 1867: Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886: Ex monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Villa San Cataldo, Bagheria, Palermo
Da gennaio 2005: Palazzo Fernandez, Palermo
Perseo trionfante è una scultura in marmo, opera di Antonio Canova realizzata tra il 1797 e il 1801. Si conserva ai Musei Vaticani a Roma. Dapprima l'opera doveva essere destinata a Giuseppe Bossi per il Foro Bonaparte a Milano; invece la statua fu acquistata da papa Pio VII nel 1802, per la considerevole cifra di tremila zecchini d’oro, e fu collocata in sostituzione all'Apollo del Belvedere, da cui Canova trasse l'ispirazione per la statua, portato dai francesi a Parigi fino al 1815. Come noto presso la Gipsoteca di Possagno si conserva il gesso originale dell’opera. Fin dal 1832, anno della consacrazione del Tempio di Possagno, Monsignor Sartori incaricò il professore di architettura all’Accademia di Belle Arti di Venezia Francesco Lazzari (1791-1871) perché progettasse la costruzione della "raccolta dei gessi". La nuova fabbrica della Gipsoteca fu completata nel 1836. Lazzari aveva edificato una grande basilica, un vero e proprio mausoleo per l'arte del grande Antonio Canova: “un Olimpo per la scultura”. L’edificio si presenta con un'alta e solenne volta a botte con cassettoni, divisa in tre settori, dove è collocato, assieme a Venere e Marte, Venere e Adone, la Maddalena Penitente, Paride, Ettore e Aiace con Napoleone Bonaparte, il gesso del Perseo. Nel 1917, durante la prima Guerra Mondiale, una granata colpì la Gipsoteca: alcuni gessi furono completamente distrutti, decine furono lesionati, scheggiati. Una grandiosa opera di restauro di Stefano e Siro Serafin, padre e figlio, consentirono di far rinascere la Gipsoteca: il portone del museo fu riaperto ai visitatori nel 1922. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per prevenire nuovi bombardamenti, la Gipsoteca fu in parte svuotata, le statue furono trasferite e depositate all’interno del Tempio di Possagno, dove rimasero fino al 1946 quando ritornarono nella loro collocazione originale. La Gipsoteca fu riallestita nel 1957 da Carlo Scarpa, che provvide anche alla sistemazione del Monumento di Maria Cristina d’Austria e all’allestimento dello spazio da lui progettato.
La statua rappresenta appunto Perseo che taglia la testa alla Gorgone Medusa. Egli non avrebbe dovuto guardare negli occhi il mostro, ma proprio perché l'ha fatto viene pietrificato e diventa una statua. Secondo la stessa e suggestiva leggenda quindi l'opera sarebbe il vero corpo di Perseo, pietrificato.
Il calco ottocentesco custodito dall'Accademia di Belle Arti di Palermo è stato realizzato, anch'esso come la scultura originale, con la tecnica a tasselli. Il metodo esecutivo si evince dai segni dei tasselli, presenti in varie zone della superficie.
Il gesso si presenta nell’insieme usurato da scalfiture in diverse parti e presenta depositi superficiali e lesioni. Molte sono le parti fratturate. Nel 1854 viene riattaccata nelle gambe e nel dorso da Carmelo Vanni dopo i danni provocati dalla bomba caduta sulla Galleria dell’Università nel 1848. Nel 1867 Vincenzo Ragusa la restaura a seguito dei danni provocati dal trasporto dall’ex Casa dei Padri Teatini all’ex monastero della Martorana. Sulla superficie sono visibili le linee di giuntura dei restauri subiti negli anni. Tra il 2005 e il 2006, in seguito ai danneggiamenti riportati dal trasloco effettuato in occasione del restauro di Palazzo Fernandez, Salvatore Rizzuti la restaura nel tronco, nel polso destro, nel braccio sinistro, nel panneggio parte sinistra, negli arti inferiori, nel panneggio in basso e alla base.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi scultori del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la tridimensionalità, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero.
Inventari oggetti di antichità della Regia Università, 1857, Fondo Archivio Storico dell’Università degli Studi di Palermo, Archivio Storico dell’Università di Palermo, Palazzo Steri; L. Tosi, L’amicizia del Canova per il Bossi alla luce di nuove lettere, Venezia 1940; G. Delfini Filippi, La Gipsoteca nel XX secolo. Note d’archivio, in Antonio Canova, Venezia 1992, pp. 369-375; M. Guderzo, La bellezza violata: i danni della grande guerra sulle opere del Canova, Possagno 2004; G. Delfini Filippi,“Allo scopo di impedire saccheggio e devastazione”: i provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio canoviano a Possagno nei giorni della Grande Guerra, in La memoria della prima guerra mondiale: il patrimonio storico-artistico tra tutela e valorizzazione, Vicenza 2008, pp. 159- 171.
Marmo, h. 129 cm
Collezione privata
Gesso, h. 129 cm
Acquistata dalla Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia o dalla Deputazione dell’Università di Palermo dal formatore Carmelo Vanni, nel 1853.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1853 - 1867 Ex Casa dei Padri Teatini, Palermo
1867 - 1886 Ex Monastero della Martorana, Palermo
1886 - 2000 Palazzo Fernandez, Palemo
2000 - 2001 Mulini Virga, Palermo
Valerio Villareale (Palermo, 1773 - settembre 1854) è stato uno scultore italiano, massimo rappresentate del gusto neoclassico in Sicilia. Considerato il Canova siciliano come recita l'epigrafe sul busto che lo commemora nella Chiesa di San Domenico, si forma alla scuola di Giuseppe Velasco. Viaggia dapprima a Napoli 1794 per lavorare alla Corte murattiana e quella borbonica per poi raggiungere Roma dove soggiornerà in due distinti periodi 1797 - 1799 e 1802 - 1811, dove incontra Antonio Canova. Dal 1814 rientra a Palermo dove svolge la sua professione fino alla morte. Partecipa alla ricostruzione del tempio di Castore e Polluce di Selinunte. Muore di colera nel 1854 ed è seppellito fra gli uomini illustri nel pantheon palermitano della Chiesa di San Domenico. La statua di Psiche è stata considerata un capolavoro del Villareale dai critici contemporanei. Dopo la morte di Villareale, avvenuta nel 1854, il suo amico Benedetto Sommariva Gamelin acquistò l’opera. Questa rimase nella casa di via Valerio Villareale al numero 22 fino al 1910, quando la proprietà fu venduta. Si pensava che l’opera era stata ritenuta perduta, la scultura, invece, è rimasta in possesso dei discendenti della famiglia Sommariva, per confluire successivamente in collezione privata.
Sul piano compositivo l’opera è separata dalla tradizionale rappresentazione di Psiche attraverso la presenza del vaso che richiama dall’oltretomba, contenente la bellezza di Persefone. Psiche non è molto lontana da una figura triste che si duole per essere stata abbandonata da Eros, ma una giovane eroina, sopraffatta dalla curiosità. Nella sua ricerca di amore e bellezza, la Psiche del Villareale serve come una meditazione sull’anima, ed è considerata uno tra i più importati dei suoi lavori dell’età matura. Scrive il Musso (1910): "opera pregevolissima da accrescere l’alta fama del Villareale è la Psiche, in marmo, che ritrae l’estro la forza dell’artista; è tale da non temere il confronto con quella del Tenerari, avendo grazia, flessibilità, morbidezza e vita insuperabili. Eppure questo capolavoro stette per molto tempo esposto in vendita senza che alcuno pensasse ad acquistarlo, aspettando lo straniero apprezzatore che lo portasse via come tutti gli altri moltissimi". Il Mazzara (1935) aggiunge che è stata compiuta nel 1933 ed è stata venduta in Inghilterra. Il Bottari (1962) scrive: "la più valida delle sue opere è la Psiche, indicata come il suo capolavoro".
Trasportata a Palazzo Fernandez nel 1886. Fu ricavata un esemplare in marmo di Villareale, oggi in collezione privata, scolpita a Roma e ispirata dalla Psiche di Bartel Thorvalsen.
L’opera non è stata ripulita, presenta macchie di resina nella gamba sinistra. È cava al suo interno e dalla fragilità, dall’impasto gessoso scadente,presenta dei fori. Incisioni evidenti lungo la gamba destra. Numerosi tasselli sul capo, sul viso e sul collo (slavature). Presenta ridipinture con liquidi che hanno ossidato l’opera. Marchiata col numero 69 sul basamento. Sulla gamba sinistra presenta delle bolle che mostrano il degrado in corso del gesso. Manca parte dell’ala destra, sulla superficie sono presenti diversi piccoli graffi e delle lesioni nella parte posteriore della schiena, nell’addome, sui gomiti di destra e di sinistra e nella gamba destra. Interventi di giuntura sono visibili nell’addome e sulla schiena e ai due gomiti.
La Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Palermo sorge nel 1815 grazie ad una raccolta di sculture importate da Roma dall’insegnante titolare di Scultura Valerio Villareale. Considerato il Canova siciliano come recita l’epigrafe sul busto che lo commemora nella chiesa di San Domenico, si forma alla scuola di Giuseppe Velasco. Sarà attivo dapprima a Napoli alla corte murattiana e borbonica, e poi a Roma dove soggiornerà in due periodi 1797-1799 e 1802-1811 dove incontra Antonio Canova. Dal 1814 rientra a Palermo dove svolge la sua professione fino alla morte. Partecipa alla ricostruzione del tempio di Castore e Polluce di Selinunte. Muore di colera nel 1854 ed è seppellito fra gli uomini illustri nel Pantheon palermitano della Chiesa si San Domenico. È stato direttore delle Belle Arti, professore di scultura alla Reale Università di Palermo, membro della Commissione di Antichità e Belle Arti 1830.
Marino Mazzara, Valerio Villareale. Scultore palermitano e l’arte in Palermo Dal 1801 al 1904, Palermo, tipografia Michele Greco, 1935; D. Malignaggi, Maurizio Calvesi, Valerio Villareale, Palermo,Luxograph, 1986; I. Bruno, Valerio Villareale. Un Canova meridionale, Palermo, Ariete, 2000; M. La Monica, Antonella Chiazza, Valerio Villareale, Palermo, Pitti, 2012.
Marmo
Basilica di Santa Maria del Popolo, Roma
Gesso, 38x163 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel novembre del 1887 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 220, p. 74).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore de Maria Bergler
1887 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Pietra arenaria, 75x865 cm
Ex Casa dei Miseremini, Centro diocesano delle Congregazioni laicali, pressi Chiesa di S. Matteo, Palermo
Gesso patinato, 75x865 cm
Acquistato dal Reale Istituto di Belle Arti di Palermo nel giugno del 1888 dal formatore Giovanni Mirabile o da Gioacchino Brocia.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
Si tratta di un fregio risalente al XIV secolo posto sotto le finestre della Casa dei Miseremini (oggi sede del Centro diocesano delle Congregazioni laicali) nella salita S. Antonio nei pressi della chiesa di S. Matteo sita in Corso Vittorio Emanuele a Palermo. La nuova chiesa di S. Matteo, iniziata nel 1633 su progetto dell’architetto Mariano Smiriglio (1569-1636), sorse di fronte alla vecchia chiesa omonima risalente al XII secolo che nel 1599 era divenuta sede della confraternita dei Miseremini, fondata nello stesso anno allo scopo di celebrare messe per le anime purganti. Non appena la nuova costruzione fu ultimata, la Congregazione vi si trasferì lasciando così che l’antica chiesa venisse incorporata nel Monastero di S. Caterina.
Il fregio in questione si rifà allo stile arabo-normanno in cui si ritrova una sottile combinazione di elementi islamici, romanici e bizantini. L’opera è caratterizzata da un modulo decorativo regolare e geometrico dove risulta evidente la tendenza alla stilizzazione nella rappresentazione di figure antropomorfe e in particolare di motivi fitomorfi costituiti da palmette e piante sottili e piatte, rigide e senza fioriture.
Il calco ottocentesco è stato sottoposto a patinatura superficiale, procedimento che consente di anticare oltre che di proteggere e impermeabilizzare l’opera. Il fregio, posto a una certa altezza, risulta scalfito in vari punti in particolare lungo fascia superiore.
Daddi, G., San Matteo vecchio e nuovo: le due chiese, 1088-1633 e l’unione dei Miseremini, Palermo 1916; Di Gristina, E., Palazzotto, E., Piazza, S., Le chiese di Palermo. Itinerario architettonico per il centro storico fra Seicento e Settecento, Sellerio Editore, Palermo 1998; Martella, T. (tesi di laurea di), Storia della Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Palermo - dalle sue origini ad oggi, A. A. 2000/2001; Rizzuti, S. (a cura di),Vicende della Gipsoteca storica dell’Accademia di Belle Arti di Palermo dal 1972 al 2015; Sessa, E., Le chiese a Palermo, Ugo La Rosa Editore, Palermo e Roma 1995.
Treccani, Enciclopedia, www.treccani.it/enciclopedia/scultura
Pietra
Cattedrale di Palermo
Gesso patinato, h. 340x153 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel gennaio del 1889 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 459, p. 78).
Giovanni Mirabile
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti
1889 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti, soprattutto nella parte inferiore sinistra, dove si evidenzia un’ampia lacuna, dovuta probabilmente a un danno di tipo antropico.
Nessun intervento documentato.
Pietra
Chiesa di Santa Maria della Catena, Palermo
Gesso patinato, 320x183 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel maggio del 1890 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 692, p. 79).
Gioacchino Brocia
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Campini
1890 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Pietra
Da uno dei due piloni angolari con apertura cieca, prospetto inferiore della Chiesa di Santa Maria La Nova, Palermo
Gesso patinato, 310x195 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel maggio del 1890 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 712, p. 80).
Gioacchino Brocia
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Campini
1890 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti, soprattutto nella zona inferiore.
Nessun intervento documentato.
Pietra
Prospetto inferiore destro di Palazzo Speciale-Montaperto di Raffadali, Palermo
Gesso patinato, 255x152 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel maggio del 1890 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 713, p. 80).
Gioacchino Brocia
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Campini
1890 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti, soprattutto nella zona inferiore.
Nessun intervento documentato.
Chiesa di Sant’Agostino, Palermo
Gesso, 358x310 cm
Acquistato dal Reale Istituto di Belle Arti di Palermo nel settembre del 1891 da Salvatore Valenti.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
Si tratta del portale laterale della chiesa di S. Agostino sita in via Francesco Raimondo, nel quartiere del Capo a Palermo. La chiesa, voluta dalle nobili famiglie Chiaramonte e Sclafani, fu realizzata nel tardo Duecento e venne completata e ingrandita nel corso dei secoli fino a quando, nei primi anni del Settecento, l’interno subì una radicale rivisitazione alla quale contribuì Giacomo Serpotta realizzando raffinati stucchi decorativi.
Su via S. Agostino si apre il portale laterale risalente all’inizio del XVI secolo. È in forma rettangolare secondo il gusto rinascimentale dell’epoca e presenta grossi girarli di foglie che si intrecciano sugli stipiti e nell’architrave alternandosi a nove tondi figurati. Sull’architrave nel tondo centrale è ritratto S. Agostino in abiti pontificali con due figure di sante martiri ai lati, S. Lucia e S. Agata: tengono con la destra una palma e con la sinistra reggono entrambe una coppa, l’una con gli occhi, l’altra con le mammelle, simboli del loro martirio. Sullo stipite a sinistra guardando dall’alto in basso, nei quattro tondi sono raffigurati in delicato bassorilievo S. Guglielmo eremita, una santa martire, S. Caterina d’Alessandria con la ruota del martirio e la Creazione di Adamo; sullo stipite a destra altri quattro tondi figurati con S. Nicola da Tolentino, due sante martiri con le palme e la Creazione di Eva. L’opera è comunemente attribuita a Domenico Gagini anche se non mancano pareri discordanti, primo fra tutti quello di Gioacchino Di Marzo per il quale "c’è qualche fondamento a sospettare, che opera di Giuliano Mancino e di Bartolomeo Berrettaro, e specialmente del primo, per il maggior pregio del disegno e dello scolpito, possa essere pure l’elegante decorazione marmorea della Chiesa di S. Agostino. È condotta in bella forma rettangolare sul gusto già prevalente del rinascimento dell’arte, ma di stile tutt’altro che gaginesco, con gli stipiti e l’architrave a fasce ornatissime".
Sin dall’anno della sua acquisizione il calco in gesso patinato è stato collocato a parete e non ha subito spostamenti, il che ha permesso una buona conservazione. Presenta lievi scalfiture e perdita di patinatura nella fascia superiore.
La conservazione dei calchi in gesso della gipsoteca accademica mira a far conoscere le opere dei grandi opere scultoree e decorative del passato. Tramite le copie gli allievi imparano ad avere dimestichezza con la storia degli stilemi, la tecnica realizzativa e il disegno dal vero.
G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI: memorie storiche e documenti, 1 vol., Edizioni Librarie Siciliane, Palermo 1979 (rist. dell’edizione originale Palermo 1880-1883).T. Martella, Storia della Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Palermo - dalle sue origini ad oggi, tesi di laurea, a. a. 2000/2001, Accademia di Belle Arti di Palermo; B. Ministeri, La chiesa ed il convento di S. Agostino a Palermo, Provincia Agostiniana di Sicilia, Palermo 1994; S.Rizzuti, Vicende della Gipsoteca storica dell’Accademia di Belle Arti di Palermo dal 1972 al 2015; E. Sessa., Le chiese a Palermo, Ugo La Rosa Editore, Palermo e Roma 1995.
Marmo
Parasta dell’ancona dei Diana, Chiesa di S. Cita, Palermo
Gesso, 118x21 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel settembre del 1891 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 840, p. 81).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore de Maria Bergler
1891 - 1933(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1933(?) - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti e risulta lacunosa nella parte superiore e inferiore.
Nessun intervento documentato.
Pietra
Cattedrale di Palermo
Gesso, 109x37 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel giugno del 1893 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 960, p. 82).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore de Maria Bergler
1893 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti e risulta lacunosa nella parte inferiore destra.
Nessun intervento documentato.
Gesso, 115x123 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Santa Rosalia, Scalone (piano terra)
Fino al 1933: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Il bassorilievo si presenta fratturato verticalmente nella parte centrale. Diverse scalfiture presenti in vari punti della superficie.
Nessun intervento documentato.
Pietra
Prospetto Chiesa di Santa Maria della Catena, Palermo
Gesso patinato, d. 83 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo tra il 1886 e il 1890(?).
1886 - 1933(?): Palazzo Fernandez, Palermo
1933(?) - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Santa Rosalia, Scalone
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche grazie alla sua collocazione a parete che ne ha limitato gli spostamenti.
Nessun intervento documentato.
Pietra
Prospetto di Palazzo Abatellis, Palermo
Gesso patinato, 115x123 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo tra il 1886 e il 1890(?).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Scalone (piano terra)
1886 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti e presenta una lacuna nell’angolo destro.
Nessun intervento documentato.
Marmo
Proveniente dalla Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, Palermo
Gesso, h. 38 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
Fino al 1933: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti e presenta una lacuna in una voluta.
Nessun intervento documentato.
Marmo, Mensola 42x160x50 cm e capitello h. 177 cm
Teatro Massimo, Palermo
Gesso, mensola 42x160x50 cm e capitello h. 177 cm
Trasferiti nel 1901 dal Teatro Massimo a Palazzo Fernandez.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala delle Veneri (mensola), Sala Civiletti (capitello)
Mensola/ Il gesso patinato (cm 42x160x50) in oggetto è copia della mensola d’ingresso del Teatro Massimo (eccetto una foglia d’acanto presente nell’originale alla base della voluta inferiore); si tratta di un elemento decorativo che ha la funzione di scaricare il peso dell’architrave della porta principale del teatro al di là del pronao.
L’ideazione della mensola rientra sicuramente nel progetto di G.B. Filippo Basile degli anni 1864-67. Se nel 1891 all’esterno della struttura erano ancora assenti i tondi e le lunette in bassorilievo - cosa che consentì a Ernesto Basile di apportare lievi modifiche ai disegni paterni degli stessi (cfr. E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, pp. 109-110) - probabilmente la realizzazione della mensola (avendo questa una funzione strutturale e non meramente estetica, indi secondaria nell’edificazione) è precedente a tale data.
Capitello/ È interessante partire da tale mensola per giungere ad analizzare un capitello progettato dallo scultore Mario Rutelli - peraltro simile a quelli del pronao ideati da G.B. F. Basile - seppur maggiormente slanciato, a testimonianza dell’imminente abbandono della tradizione accademica che, con elegante sobrietà, invece di citare, rivisita.
Rutelli, autore della Lirica (1897), gruppo bronzeo d’ingresso, aveva già lavorato con G.B. F. Basile (cfr. E. Sessa, op. cit., pp. 109, 113); la datazione del capitello (alto, come il gesso “originale” tratto dal modello in creta, cm 177) deve essere antecedente al 1891, data di morte dell’architetto. Tale ipotesi è rafforzata dal disegno di un capitello del 1886, a firma Ernesto Basile, realizzato in occasione del Secondo concorso per il Palazzo di Giustizia di Roma, con esplicito riferimento ai prototipi paterni dei capitelli del teatro (cfr. E. Mauro, E. Sessa, Giovan Battista…, 2000, pp. 104-105).
Mensola/ Classica è l’iconografia dell’opera - ascrivibile a uno stile accademico - lateralmente adorna di girali fitomorfe e delimitata in entrambe le estremità da volute fiorate, raccordate da una sinuosa fettuccia scanalata e rimarcata da un cordone di forme ovoidali consecutive.
Frontalmente, invece, è composta di due fasce simmetriche di foglie fra loro adiacenti e divergenti rispetto a un ulteriore cordone centrale. Si tratta di foglie d’ulivo (cfr. A. Di Roma, La produzione…, 2008, pp. 54-55), pianta sacra alla dea Atena che di lì a poco sarebbe assurta a «patrona della Secessione» Viennese (E. di Stefano, La Secessione…, 1999, p. 21), simbolo della modernità che si impone.
Il gesso, quasi sicuramente trasferito nel 1901 dal teatro al Palazzo Fernandez, è tuttora ivi conservato, nella Sala delle Veneri dove, grazie all’alta collocazione a parete, si è potuto mantenere in ottimo stato (cfr. T. Martella, Storia dellla Gipsoteca…, 2001, p. 50).
Capitello/ Dotato di abaco dagli spigoli concavi - impreziosito da ovoli e dardi e sorretto al vertice da una doppia voluta liscia (sostitutiva dei caulicoli) con foglia centrale di curvatura divergente - il capitello interpreta in chiave più morbida il frastagliato di ordine corinzio, grazie a due corone di foglie d’acanto, dalle quali se ne dipartono due più affusolate e simmetriche rispetto alla voluta.
Quanto al fiore dell’abaco, si può supporre racchiuda sinteticamente la simbologia di nascita e morte, mirabilmente illustrata da Bergler negli affreschi di Villa Igea (cfr. M. Briguglia, Ettore De Maria…, 1988, pp. 64, 68), insita nelle sue componenti - petali di giglio e capsula di Papaver somniferum - in linea con la manipolazione dell’elemento floreale attuata dal Basile, in vista di una sua trasfigurazione simbolica (cfr. P. Portoghesi, S. Lo Nardo, G. Fiume, Ispirandosi all’Orto…, 1996, pp. 53-56, 61).
Per la provenienza e lo stato di conservazione del gesso, valgono le medesime informazioni di quello relativo alla mensola, a eccezione dell’attuale ambiente di collocazione all’interno del Palazzo Fernandez (cfr. T. Martella, op. cit., 2001, p. 50) ovvero la Sala Benedetto Civiletti, adibita a Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti.
M. Briguglia, Ettore De Maria…, 1988, pp. 64, 68; P. Portoghesi, S. Lo Nardo, G. Fiume, Ispirandosi all’Orto…, 1996, pp. 53-56, 61; E. di Stefano, La Secessione…, 1999, p. 21; E. Mauro, E. Sessa, Giovan Battista…, 2000, pp. 104-105; T. Martella, Storia dellla Gipsoteca…, 2001, p. 50; E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, pp. 109-110; A. Di Roma, La produzione…, 2008, pp. 54-55.
Pietra arenaria, 120x36 cm cad.
Caffè del Teatro Massimo, Palermo
Gesso, 120x36 cm cad.
Teatro Massimo (1901)
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore De Maria Bergler (direzione)
Trattasi delle copie in gesso (cm 120x36) delle formelle scolpite a medio rilievo nella stessa pietra del prospetto del Teatro Massimo e inserite negli architravi di tre dei finestroni del caffè annesso. Realizzate (come tutti gli elementi decorativi) nel 1893-97 (cfr. E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, pp. 109-110), in stile proto-Liberty, presentano soggetti ornamentali che ben si addicono all’ambiente ristorativo per il quale sono stati ideati, enucleando temi come il gelato (a), il fumo (b) e la natura morta (c), espressi da elementi simbolo di fertilità e ricchezza, «non scevri da accenni ai paradisi arabo-siculi». (G. Pirrione, Il Teatro Massimo…, 1984, p.148)
a) N. inv. 139 - Doppio incrocio di tralci di agrumi e fichi tenuti fermi da due nastri, a loro volta legati a degli accessori del pozzetto a tino (cfr. G. Pirrione, ibidem) in assi in legno, dal quale sono posti equidistanti.
b) N. inv. 140 - Incrocio di pipe decorate con gusto asimmetrico, divergenti specularmente rispetto a un’anfora-narghilè (cfr. G. Pirrione, ibidem) e associate per coppie orizzontali, di cui quella inferiore prevede terminazioni antropomorfe.
c) N. inv. 141 - Alzatina con frutta (melograni e uva) e probabilmente fiori di corbezzolo (cfr. G. Pirrione, ibidem), pianta simbolo del tricolore e dell’Unità d’Italia per il verde delle foglie, associato al bianco dei fiori e al rosso dei frutti.
A sinistra erompe infatti una testa dalla folta capigliatura e barba ondulata, mentre a destra ne emerge un’altra dai lineamenti grossolani di un uomo glabro, adorna di copricapo. Tale figura - marcatamente caratterizzata nella sua fisionomia, dal naso prominente e dalla bocca sgraziatamente aperta a indicare un’espressione attonita - ricorda le fattezze caricaturali tipiche delle maschere del teatro greco. Il gusto per simili infiorescenze encefaliche affonda le sue radici nello sbocciare di teste (umane o animali) da tralci vegetali, nell’ambito di ibridismi di origine asiatica, poi diffusi nel Mediterraneo (specie nei secoli XII-XIII) come Alberi della Vita dalle multiformi teste (cfr. J. Baltrušaitis, A. Gheerbrant, Il Medioevo…, 2012, pp. 135-137, 144). Tale iconografia metamorfica rientra in quella dei grilli e delle grottesche, riccamente presenti nelle decorazioni ad affresco del Villino Favaloro, progettato nel 1889 da G.B. F. Basile e completato dal figlio Ernesto nel 1914, in uno stile di passaggio dall’Eclettismo al Modernismo (cfr. A. Chirco, M. Di Liberto, Via Dante…, 2011, pp. 60-63). Quanto al motivo della pipa raffigurata nella formella, si nota come la forma fallica alluda all’universo maschile, anche se racchiude un doppio simbolismo sessuale nell’associazione di fornello (energia femminile) e cannello (energia maschile). Tale interpretazione, insieme con l’acqua dell’anfora, rafforza il tema della ciclicità della vita, sottolineato anche dal nastro quasi cuoriforme evocativo del segno di infinto. A completamento dello sviluppo orizzontale della decorazione si spiegano, apparentemente speculari, due nastri simili nelle volute a quelli che Ernesto Basile adopererà per il fregio della Cassa di Risparmio.
Per quanto concerne la provenienza dei gessi, si ipotizza un trasferimento degli stessi nel 1901, dal Teatro Massimo al Palazzo Fernandez, nel quale sono tuttora collocati (Sala Ettore De Maria Bergler adibita alla Direzione) a parete, la qual cosa ha finora garantito un buono stato di conservazione (cfr. T. Martella, Storia della Gipsoteca…, 2001, p. 50) nonostante alcuni punti presentino scalfitture.
E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, pp. 109-110G. Pirrione, Il Teatro Massimo…, 1984, p.148J. Baltrušaitis, A. Gheerbrant, Il Medioevo…, 2012, pp. 135-137, 144A. Chirco, M. Di Liberto, Via Dante…, 2011, pp. 60-63T. Martella, Storia della Gipsoteca…, 2001, p. 50
Marmo, capitello 150x160x40 cm e fregio 180x95x60 cm
Palazzo della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, Palermo
Gesso, capitello 150x160x40 cm e fregio 180x95x60 cm
Probabile donazione di Ernesto Basile, anni venti-trenta del XX sec.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti (capitello) e Sala delle Veneri (fregio)
Quanto alla provenienza dei gessi, si può dire incerta per entrambi, poiché non registrati nel giornale d’entrata delle acquisizioni della gipsoteca dell’Istituto di Belle Arti, la qual cosa fa ipotizzare una donazione informale degli stessi da parte del prof. Basile, databile tra il secondo e il terzo decennio del Novecento.
L’ottima conservazione dei gessi è garantita dall’alta collocazione a parete degli stessi (T. Martella, op. cit., pp. 26, 50-51), precisamente nella Sala delle Veneri (fregio) e nella Sala Salvatore Valenti (capitello) di Palazzo Fernandez.
I gessi relativi al capitello e a una porzione del fregio (quest’ultimo “originale” ovvero derivato dal prototipo in argilla modellato dall’autore) progettati da Ernesto Basile per la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, sita nell’ormai omonima piazza di Palermo (ex piazza Borsa), misurano rispettivamente cm 150x160x40 e cm 180x95x60 (cfr. T. Martella, Storia della Gipsoteca…, 2001, pp. 50-51). Se il primo risale al 1911, il secondo si può ipotizzare coevo o comunque datare al periodo 1907-12, date di ideazione della sede (cfr. E. Mauro, E. Sessa, Giovan Battista…, 2000, p. 238), e in specie dopo il 1908, anno della terza e ultima stesura progettuale del Palazzo dell’Aula dei Deputati a Montecitorio di Roma (cfr. E. Mauro, E. Sessa, Ernesto Basile a Montecitorio…, 2000, p. 17), emblematico del nuovo sistema architettonico, perfezionato proprio per la Cassa di Risparmio di Palermo (cfr. E. Sessa, Ernesto Basile, 1857-1932:fra accademismo…, 2010, pp. 74-75).
Quasi sovrapponibile a quella del fregio che corona le finestre del piano rialzato di Palazzo Montecitorio (cfr. M. Marafon Pecoraro, E. Marrone, Lo studio Basile…, 2013, p. 35) risulta infatti l’iconografia del fregio bancario che, come il relativo capitello, presenta un cartiglio retto da un nastro, artificioso nel suo moto ondoso, reso segmentato e chiaroscurato.
Il monogramma “CR” (iniziali di “Cassa” e “Risparmio”), che si staglia sinuoso sui cartigli lapidei, denota nel fregio (per l’incompletezza delle lettere) la sua natura angolare (mutila) e richiama il medesimo motivo decorativo-grafico che Basile adotta per l’etichetta del vino Maganoce (1910) (cfr. E. Mauro, E. Sessa, Giovan Battista… op. cit., pp. 253-254). Tale assonanza è ascrivibile all’ideale di arte totale e immagine coordinata ante litteram che caratterizza tutta l’Art Nouveau, come confermano le decorazioni degli arredi progettati per la Cassa di Risparmio (cfr. E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, p. 313).
Il capitello - previsto da progetto per la sommità delle due paraste esterne del secondo ordine della facciata - è avvolto da una griglia di nastri (sostitutivi del collarino nei loro componenti orizzontali) che, oltre a sorreggere il cartiglio frontale, sono impreziositi da fiocchi nei punti di sostegno dei due rami di ligustro. Questi (convergenti nelle diramazioni interne e divergenti in quelle esterne), caratteristici anche del fregio, corrispondono alle linee strutturali create dai caulicoli (viticci fuoriuscenti dalle foglie d’acanto e arrotolati a spirale sotto l’abaco) nei classici capitelli corinzi, rendendo tali elementi dell’istituto bancario espressione dell’avvenuto passaggio graduale dall’accademismo al Liberty. Al centro di tale fascia, quasi traforata nei piccoli spazi tra una foglia e l’altra, campeggia, rigorosamente infiocchettato, un salvadanaio (sostituito al fiore solitamente posto fra le volute dei caulicoli) quale emblema del risparmio (cfr. E. Mauro, E. Sessa, Giovan Battista… op. cit., pp. 238-239), la cui fessura atta a inserire le monete è ammorbidita in una tilde inclinata. Tale energia, vibrante seppur regolata, tipica della ricerca di un rinnovato sistema architettonico, si riflette nella simbologia tanto del nastro - vita, trionfo (cfr. J. Baltrušaitis, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli…, 2012, p. 120) - quanto della pianta che, con le sue foglie turgide, glabre e lanceolate, allude alla giovinezza e alla prosperità, nel solco di una rinascita primaverile che caratterizza lo scenario artistico internazionale.
E. Mauro, E. Sessa, Giovan Battista…, 2000, p. 238; E. Mauro, E. Sessa, Ernesto Basile a Montecitorio…, 2000, p. 17; T. Martella, Storia della Gipsoteca…, 2001, pp. 50-51; E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, p. 313; E. Sessa, Ernesto Basile, 1857-1932:fra accademismo…, 2010, pp. 74-75; J. Baltrušaitis, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli…, 2012, p. 120; M. Marafon Pecoraro, E. Marrone, Lo studio Basile…, 2013, p. 35.
Gesso, h. 68x60 cm
Donato al R. Istituto di Belle Arti di Palermo da Ernesto Basile agli inizi del Novecento.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
Fino al 1933: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Trattasi di un gesso "originale" - ovvero derivato dal prototipo in argilla - di una faccia dell’elemento di base dei lampioni progettati dall’architetto Ernesto Basile per la cancellata del Teatro Massimo (cfr. T. Martella, Storia della Gipsoteca…, 2001, p. 51).
L’intero complesso di alzati di candelabro bronzei, deputati all’illuminazione di Piazza Verdi, risale al 1897 (cfr. E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, p. 111) , data di inaugurazione del teatro nonché di conclusione degli interventi decorativi realizzati negli ambienti interni da Ettore De Maria Bergler a partire dal 1893. Sulle pareti della Sala Pompeiana Bergler affresca dei labari dorati, esplicito richiamo - nell’elemento verticale - ai lampioni della piazza, per creare (come già nel Salotto d’Estate di Villa Whitaker, decorato con la riproduzione di una serra affacciantesi su piante esotiche) una corrispondenza tra esterno e interno (cfr. M. Briguglia, Ettore De Maria…, 1988, pp. 47, 60). Si tratta di un periodo particolarmente propizio per Basile che nel 1891 assume la direzione dei lavori del cantiere del teatro, anno della morte del padre G.B. Filippo e dell’Esposizione Nazionale tenutasi a Palermo. Nel 1888, per la stessa, Basile aveva ricevuto l’incarico di progettare la cittadella effimera, ruolo che gli procura notevole rilevanza consacrandolo a modello per le nuove generazioni (cfr. E. Sessa, Ernesto Basile, 1857-1932: fra accademismo e…, 2010, pp. 7-8, 16). L’elemento centrale del gesso in oggetto, costituito da una conchiglia di matrice rinascimentale affiancata da due foglie d’acanto, è sorretto da zampe leonine raccordate da simmetrici riccioli vegetali congiunti.
La sinuosità a colpo di frusta delle foglie d’acanto - ammorbidite rispetto a quelle rigide di epoca classica che citano e reinterpretano - è significativa del passaggio che avveniva in quegli anni dall’Eclettismo allo stile Liberty e suggerisce, insieme agli altri elementi costitutivi del gesso, una iconografia legata alla fecondità: la conchiglia (cfr. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli…, 2011, pp. 309-310) e il proliferare di decorazioni fitomorfe.
I componenti dell’opera sono infine uniti da una corda annodata, simbolo di vita o di legame, simbologia particolarmente diffusa in ambito massonico (cfr. J. Chevalier, A. Gheerbrant, ibidem, pp. 318-319); a tal proposito si consideri l’ettagono del lucernaio della Sala Pompeiana (cfr. M. Briguglia, op. cit., p. 60).
Donato al Regio Istituto di Belle Arti di Palermo dallo stesso prof. Basile agli inizi del 1900, il gesso - scalfito in diverse parti - è stato collocato nei locali di Palazzo Fernandez fino al 1933, anno in cui venne trasferito presso il Palazzo Santa Rosalia, per poi tornare nella precedente sede (eccetto per gli anni 2000-01 in cui si trovò ai Mulini Virga) dov’è tuttora posto (cfr. T. Martella, op. cit., p. 51) nel soppalco della Direzione.
Il calco in gesso è cavo, probabilmente soggetto a patinatura, è scalfito in vari punti. Nell’insieme si presenta in accettabile stato di conservazione.
T. Martella, Storia della Gipsoteca…, 2001, p. 51; E. Sessa, Ernesto Basile. Dall’Eclettismo…, 2002, p. 111; M. Briguglia, Ettore De Maria…, 1988, pp. 47, 60; E. Sessa, Ernesto Basile, 1857-1932: fra accademismo e…, 2010, pp. 7-8, 16; Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli…, 2011, pp. 309-310.
Gesso, h. 166 cm
Dono dell’autore, assieme ad altri 13 gessi originali, all’Accademia di Belle Arti di Palermo prima della morte (1950).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Archimede Campini
1950(?) - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2004: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione. La superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Tra il 2009 e il 2011 Sophie Bonetti, in collaborazione con gli alunni del Corso di Restauro, ne effettuano la pulitura.
Campini Archimede scultore, Accademia di Belle Arti, IRES, Palermo [s.d.] 1951(?); Archimede Campini, catalogo della mostra (Palermo, Accademia di Belle Arti, 1993), Palermo 1993.
Gesso, 290x150x115 cm
L’opera in marmo, realizzata postuma (1951-1953), per sostituire il gruppo scultoreo tardo cinquecentesco di Vincenzo Gagini, distrutto dai bombardamenti bellici, é conservata presso la Chiesa della SS. Trinità o Magione, Palermo
Dono dell’autore, assieme ad altri 13 gessi originali, all’Accademia di Belle Arti di Palermo prima della morte (1950).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Campini
ante 1950 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la struttura portante in legno evidenzia notevoli problematiche strutturali. La superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Campini Archimede scultore, Accademia di Belle Arti, IRES, Palermo [s.d.] (1953 ?); Archimede Campini, catalogo della mostra (Palermo, Accademia di Belle Arti, 1993), Palermo 1993; C. De Seta, M. A. Spadaro, F. Spatafora, S. Troisi, Palermo città d’arte. Guida illustrata ai monumenti di Palermo e Monreale, Palermo, Kalos, 2009, p. 247.
Gesso, 42x120 cm
Dono dell’autore, assieme ad altri 13 gessi originali, all’Accademia di Belle Arti di Palermo prima della morte (1950).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Campini
ante 1950 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione; manca parte della zona inferiore. La superficie si presenta lievemente scalfita in diversi punti.
Campini Archimede scultore, Accademia di Belle Arti, IRES, Palermo [s.d.] (1953 ?); Archimede Campini, catalogo della mostra (Palermo, Accademia di Belle Arti, 1993), Palermo 1993.
Gesso, h. 57 cm
Dono dell’autore, assieme ad altri 13 gessi originali, all’Accademia di Belle Arti di Palermo prima della morte (1950).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Santa Rosalia, Uffici Direzione Amministrativa
ante 1950 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione. La superficie si presenta lievemente scalfita in diversi punti.
Campini Archimede scultore, Accademia di Belle Arti, IRES, Palermo [s.d.] (1953 ?); Archimede Campini, catalogo della mostra (Palermo, Accademia di Belle Arti, 1993), Palermo 1993.
Gesso patinato avorio e dorature, 170x135 cm
Prototipo in gesso patinato della targa in bronzo collocato nella Tomba di Dante, Ravenna
Dono dell’autore, assieme ad altri 13 gessi originali, all’Accademia di Belle Arti di Palermo prima della morte (1950).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Scalone (terzo piano)
1950(?) - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Campini Archimede scultore, Accademia di Belle Arti, IRES, Palermo [s.d.] (1953 ?); C. Ricci, Il sepolcro e le ossa di Dante, Ravenna, Longo 1977; Archimede Campini, catalogo della mostra (Palermo, Accademia di Belle Arti, 1993), Palermo 1993.
Gesso patinato, h. 46 cm
Dono dell’autore, assieme ad altri 13 gessi originali, all’Accademia di Belle Arti di Palermo prima della morte (1950).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
ante 1950 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta lievemente scalfita in alcuni punti.
Campini Archimede scultore, Accademia di Belle Arti, IRES, Palermo [s.d.] (1953 ?); Archimede Campini, catalogo della mostra (Palermo, Accademia di Belle Arti, 1993), Palermo 1993.
Gesso patinato, h. 150 cm
Opera in marmo, 1938, Ingresso Via Roma, Palermo (opera vincitrice Concorso Nazionale), Collezione privata.
Dono dell’autore, prima della morte (1975).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1936/38(?) - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione. La superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Vigorose impronte. Pina Calì pittrice, Silvestre Cuffaro scultore, catalogo della mostra (Museo Guttuso, Bagheria 2005) a cura di P. Ferruzzi, Bagheria 2006, p. 344, n. 72.
Pietra
Chiesa di S. Maria della Grazia detta delle Repentite, Palermo
Gesso patinato, 614x180 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel maggio del 1890 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 719, p. 80).
Gioacchino Brocia
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Campini
1890 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti, soprattutto nella zona inferiore.
Nessun intervento documentato.
Pietra arenaria
Cattedrale di Palermo
Gesso patinato, 480x146x70 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel settembre del 1891 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 832, p. 81) da Salvatore Valenti.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1891 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti, soprattutto nella zona inferiore.
Nessun intervento documentato.
Pietra arenaria
Cattedrale, Palermo
Gesso patinato, 375x175 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel settembre del 1891 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 835, p. 81) da Salvatore Valenti.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1891 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti, soprattutto nella zona inferiore.
Nessun intervento documentato.
Pietra arenaria
Cattedrale, Palermo
Gesso patinato, 116x105x44 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel settembre del 1891 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 836, p. 81) da Salvatore Valenti.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1891 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Pietra
Duomo, Monreale
Gesso patinato, h. 210 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel settembre del 1891 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 837, p. 81) da Salvatore Valenti.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1891 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Marmo
Teatro Massimo, Palermo
Gesso, 85x100 cm
Donato da Salvatore Valenti nel settembre del 1891 al R. Istituto di Belle Arti di Palermo (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 844, p. 81)
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Salvatore Valenti
1891 – 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Rilievo in pietra collocato nel frontone del prospetto principale del Banco di Sicilia, Palermo.
Gesso, 55x154x26 cm
Dono dell’autore, assieme ad altri 13 gessi originali, all’Accademia di Belle Arti di Palermo prima della morte (1950).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli.
1950 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la struttura portante in legno evidenzia notevoli problematiche strutturali. La superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Archimede Campini, catalogo della mostra (Palermo, Accademia di Belle Arti, 1993), Palermo 1993; Campini Archimede scultore, Accademia di Belle Arti, IRES, Palermo [s.d.]; M. A. Spadaro, scheda VII (Banco di Sicilia), in C. De Seta, M. A. Spadaro, F. Spatafora, S. Troisi, Palermo città d’arte. Guida illustrata ai monumenti di Palermo e Monreale, Palermo, Kalos, 2009, p. 101.
Marmi mischi
Chiesa del Gesù (Casa Professa), Palermo
Gesso, 146x111 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel dicembre del 1898 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 1461, p. 85).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1898 - 1933: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2001: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Legno dipinto
Cappella Palatina, Palazzo dei Normanni, Palermo
Gesso, 80x192x147 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo nel dicembre del 1899 (v. Giornale d’entrata e d’uscita degli oggetti mobili dell’inventario del R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal 1886 al 1922, n. ordine 1513, p. 86).
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
1899 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Marmo, h. 178 cm
Sale Borromaiche, Grande Museo del Duomo, Milano
Gesso, h. 178 cm
Donato al R. Istituto di Belle Arti di Palermo dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1896.
Probabilmente formatore milanese.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
1891 - 1892: Esposizione Nazionale di Palermo
1892 - 1896: Ex Casa dei Padri Filippini, Museo Nazionale, Palermo
1896 - 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000 - 2001: Villa San Cataldo, Bagheria
Manca l'indice della mano sinistra. La superficie di gesso mostra dei graffi in molti punti.
Audot Padre, L’Italia descritta e dipinta. Con le sue isole Siclia, Sardegna, Malta, l’isola di Calipso, ecc, tomo IV, Regno Lombardo-Veneto e minori Stati vicini, Torino 1834, p. 195; A. Gallo,Vita di Angelo Marini siciliano, insigne scultore ed architetto del secolo XVI, Palermo 1862; G. Benati, Angelo Marini il Siciliano, nuove tracce biografiche, in «Nuovi Annali.Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano», 1, 2009 (2010), pp. 157-171; F. Repishti, Pio IV e il monumento di Giangiacomo Medici nel Duomo di Milano (1560 – 1565), in «Nuovi Annali.Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano», 2, 2010 (2011), pp. 23-42.
Musei Capitolini, Roma
Gesso, h. 70 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
Fino al 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
L’opera si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Marmo, dall’Ara Pacis, Roma (?)
Gesso, 184x98 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
Fino al 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Pietra arenaria
Palazzo Marchesi(?), Palermo
Gesso, 145x116 cm
Acquistato dal R. Istituto di Belle Arti di Palermo tra il 1886 e il 1890.
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Campini
1886/90 - 2001: Palazzo Fernandez, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione.
Nessun intervento documentato.
Marmo
Gesso, 112x44 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Ettore Maria Bergler
Fino al 2000: Palazzo Fernandez, Palermo
2000-2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
Marmo
Gesso, 23x79x28 cm
Accademia di Belle Arti di Palermo - Palazzo Fernandez, Sala Mario Rutelli
Fino al 1933: Palazzo Fernandez, Palermo
1933 - 2000: Palazzo Santa Rosalia, Palermo
2000 - 2001: Mulini Virga, Palermo
Nell’insieme si presenta in buono stato di conservazione, anche se la superficie si presenta scalfita in diversi punti.
Nessun intervento documentato.
